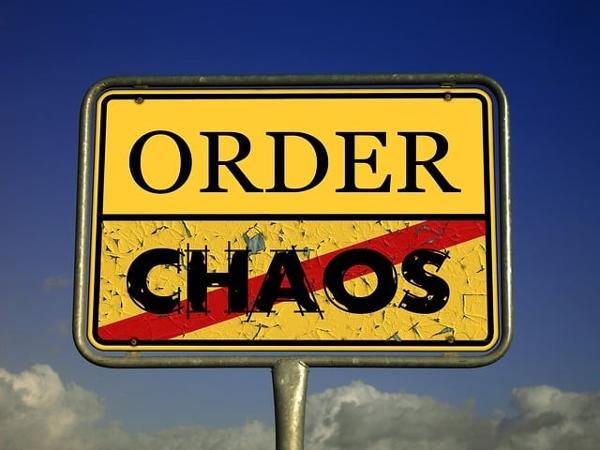FONTI FOSSILI | 150 ARTICOLI
La Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, n.2022/2464, nota come CSRD) è stata approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 dicembre 2022 e dovrà essere recepita entro 18 mesi dagli Stati membri.
Il GPL e i suoi sviluppi bio e rinnovabili come energia “giusta” per la mobilità ed il settore civile ed industriale: questo il file rouge che ha attraversato la LPG Week, il principale evento mondiale sul GPL organizzato ogni anno dalla World LPG Association e dalla Liquid Gas Europe. Ad ospitare questa vetrina, dal 13 al 17 novembre, è stata Assogasliquidi-Federchimica, associazione industriale di riferimento in Italia, presso il Nuovo Centro Congressi di Roma, la Nuvola.
Sono molti gli interessi in gioco e, allo stesso tempo, i nodi della relazione tra Iraq e Turchia, che si giocano sul piano economico-commerciale, securitario, infrastrutturale, energetico e idrico. Oltre ai due storici fiumi Tigri ed Eufrate, la cui gestione da parte turca (e non solo) sta causando a Baghdad numerosi problemi di scarsità idrica, Iraq e Turchia condividono un confine di più di 350 km. Si tratta di una frontiera dal valore strategico per l’Iraq in quanto rappresenta l’unico vero sbocco per il Paese – e per le sue risorse – verso il continente europeo.
Il mestiere del banchiere centrale è inerentemente complesso. Lo diventa ancor più sotto l’effetto della spettacolarizzazione mediatica cui – nostro malgrado – risponde oggi quell’attività che, un tempo, un certo A. Greenspan definì come quella di cui chi la esercita dovrebbe non parlarne od al massimo farlo tra le righe e con un “farfugliare incoerente”.Ed invece siamo qui – e chi vi scrive fa esercizio di astinenza al riguardo – a sondare ogni pixel delle inesauste attività comunicative multimodali delle schiere di banchieri centrali nostrani, transatlantici e del quadrante oceanico.
Recent events have underscored the importance of the United States to the global oil market…and of global supply & demand developments for the US market.
The US remains the world’s largest oil consumer…and the largest oil producer. The US Energy Information Administration (EIA) projects that domestic oil consumption will rise slightly (+0.6%) this year to 20.1 million barrels per day (Mb/d), largely due to increasing gasoline use amid continued economic growth.
Gli eventi recenti hanno sottolineato l’importanza degli Stati Uniti per il mercato petrolifero globale, ma hanno anche messo in luce quanto le dinamiche a livello mondiale influenzino gli equilibri di domanda e offerta del mercato statunitense. D’altronde, gli USA rimangono il più grande consumatore e produttore di petrolio al mondo. L’Energy Information Administration (EIA) statunitense prevede che il consumo interno di petrolio aumenterà del +0,6%, quest’anno, portandosi a 20,1 milioni di barili al giorno (mil. bbl/g), in gran parte in ragione di una maggiore richiesta di benzina, sostenuta da un contesto di continua crescita economica.
Se è vero che non è sempre facile prevedere l’andamento del prezzo del petrolio, frutto simultaneo di variabili economiche e geopolitiche, è altrettanto vero che quest’ultima corsa del Brent è stata ampiamente preannunciata, da banche d’affari, trader e accademici. Solo a titolo di esempio, già nel mese di luglio sul Blog di Energia Alberto Clo ipotizzava il raggiungimento di quota 100.
Come mai il prezzo del petrolio è diventato prevedibile? E a distanza di pochi anni da quando il WTI stupì tutto il mondo finendo sotto zero?
Lo scorso 12 luglio l’International Gas Union (IGU) – di cui sono Vice Presidente e futuro Presidente per il triennio 2025-2028 – ha pubblicato il suo 14° Report sul mercato del GNL a livello globale, presentandolo nel corso della conferenza internazionale LNG2023 tenutasi a Vancouver. Il report è la fonte pubblica di informazioni più completa al mondo sui principali sviluppi e tendenze nel gas naturale liquefatto e vuole essere uno strumento di condivisione e riflessione sul settore, mai come in questi tempi al centro anche di un’informazione più generalista.
The Russian invasion of Ukraine and subsequent cut in pipeline gas exports to Europe created a massive imbalance in the fundamental outlook for the global supply and demand of gas. Whether or not some or all this Russian gas comes back into the market, the US LNG industry has wasted no time in trying to fill this potential supply gap by aggressively moving ahead with both multiple greenfield LNG projects and project expansions.
L'invasione russa dell’Ucraina e il successivo taglio delle forniture all’Europa ha creato un disequilibrio nei fondamentali di mercato a livello globale. Indipendentemente dal fatto che alcuni di questi volumi di gas russo potrebbero ritornare sui mercati europei, l’industria del GNL americano non ha sprecato tempo ed ha cercato immediatamente di colmare il vuoto di offerta creatosi, portando avanti l’espansione di diversi progetti di GNL. Circa 100 miliardi di metri cubi annui di nuova capacità di liquefazione statunitense potrebbero essere immessi nel mercato nella seconda metà del decennio.