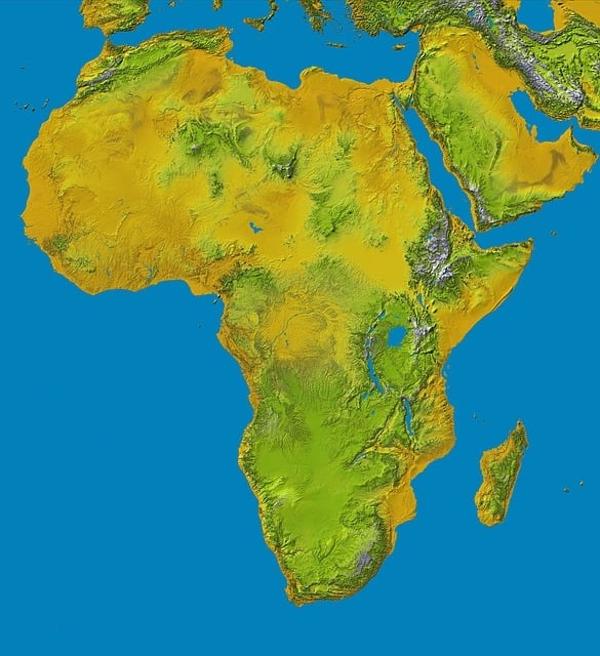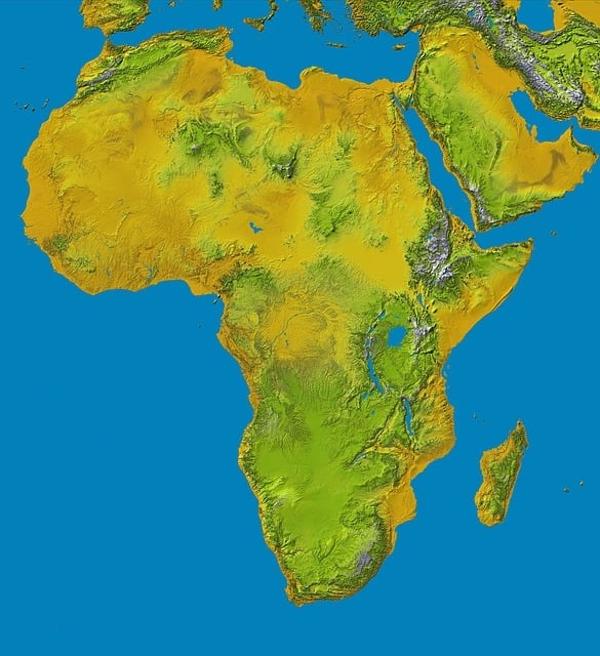La ventottesima Conferenza delle Parti (COP 28) ha segnato alcuni importanti progressi, riuscendo ad allocare risorse per le perdite e i danni legati ai cambiamenti climatici, registrando l’impegno a incrementare l’uso di fonti alternative come l’energia nucleare e garantendo sostegno alle tecnologie per l’abbattimento dei gas serra. Soprattutto, è la prima volta che un vertice COP sottolinea il nesso tra climate change e la salute pubblica, con i rappresentanti governativi di oltre cento paesi ad impegnarsi per la riduzione dell’inquinamento ambientale e di quello domestico, causa diretta di circa sette milioni di decessi all’anno (da decenni).
Doveva essere la COP dell’uscita dalle fonti fossili. È stata la COP dei compromessi. Ma per un paese come la Cina, il maggiore inquinatore al mondo, non poteva essere diversamente. Pechino ha da tempo impugnato le redini della corsa alla transizione energetica, ma rimane pragmaticamente ancorata a un sistema che sa non poter ancora stravolgere.
Ogni anno, a partire dalla prima COP di Berlino nel 1995, il mondo si riunisce per decidere come affrontare la sfida del cambiamento climatico. Alla COP21 di Parigi, nel 2015, per la prima volta, vennero assunti impegni vincolanti per limitare il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5°C, superata la quale, secondo la scienza, l’impatto del cambiamento climatico risulterebbe catastrofico.
Il 13 dicembre 2023, si sono ufficialmente conclusi i lavori della COP28 tenuta a Dubai, che ha visto coinvolti quasi 200 paesi e 90 mila delegati da tutto il mondo per affrontare, sulla base di studi scientifici, quello che viene indicato dalla banca mondiale come uno dei maggiori rischi dei prossimi anni: il cambiamento climatico e le strategie di contenimento delle temperature globali.
Esattamente un anno fa, su queste pagine, tracciavamo un bilancio energetico del 2022 appena trascorso attraverso la lettura congiunta degli angoli del “trilemma dell’energia”. Il 2022 è stato l’anno in cui l’Europa e i suoi Paesi Membri si sono riscoperti vulnerabili dal punto di vista energetico. Si è posto il problema dell’accessibilità economica dell’energia; i prezzi del gas naturale nell’hub olandese TTF hanno raggiunto picchi di oltre 350 €/MWh nel terzo trimestre del 2022.
Dove stiamo andando? Il 2024 rappresenterà un punto di rottura? Ci immetterà su un sentiero nuovo della transizione energetica? Porsi domande del genere potrebbe apparire retorico ma non lo è. Con il 2024, infatti, ci avviciniamo al punto centrale del decennio critico, quel 2020-2030 così importante poiché diverse istituzioni hanno formalmente espresso obiettivi da raggiungere nel 2030.
Ha preso il via ieri, 04 giugno 2023, la Conferenza sui cambiamenti climatici di Bonn, che fino al 15 giugno riunirà in Germania (per la 58esima volta) gli organi sussidiari dell’Unfccc, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. È la prima occasione che hanno di incontrarsi le parti dell’Unfccc, dalla Conferenza Onu sul clima svoltasi lo scorso novembre a Sharm el-Sheikh: l’obiettivo adesso è di sviluppare un approfondimento tecnico sui risultati raggiunti nel corso della Cop27 egiziana, in modo tale che i semi di questo confronto possano trovare terreno politico fertile durante la Cop28 prevista tra fine novembre e metà dicembre negli Emirati Arabi Uniti.
Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) si apprestano ad ospitare la ventottesima Conferenza delle Parti (COP 28) della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici. Il Summit si svolgerà in un momento d’importanza critica per la transizione energetica verso un futuro ad emissioni zero e, per la prima volta, si terrà in un paese del Golfo Persico principalmente noto per essere un grande esportatore di energie fossili.
In a bid to align with the obligation of the 2015 Paris Agreement to limit global warming to well below 2 Degrees Celsius, ideally 1.5 Degrees compared to pre-industrialised levels, more and more countries are introducing strategies to reduce their national emissions of greenhouse gases (GHGs) over the coming decades. Moreover, the findings from the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change published in 2023, show that serious commitments in the reduction of GHGs need to be made as a matter of urgency to keep with the temperature limit. In the wake of the United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties (COP28) that will take place in the United Arab Emirates in November 2023, several countries have enacted laws and policies that evidence their commitment to becoming carbon neutral.
Nel tentativo di allineare le politiche per limitare il riscaldamento climatico con gli Accordi di Parigi del 2015, contenendo così l’aumento della temperatura ben al di sotto dei 2° e, idealmente, a 1,5° se comparato con i livelli pre-industriali, sempre più paesi stanno introducendo strategie per ridurre le emissioni di gas serra nei prossimi decenni. Un’azione che, come emerge dai risultati del sesto Assessment Report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), pubblicato nel 2023, non è più procrastinabile. In previsione di COP28, evento che si terrà negli Emirati Arabi Uniti a novembre 2023, diversi paesi hanno promulgato leggi e politiche che evidenziano il loro impegno a traguardare un’economia net zero carbon nel lungo periodo.