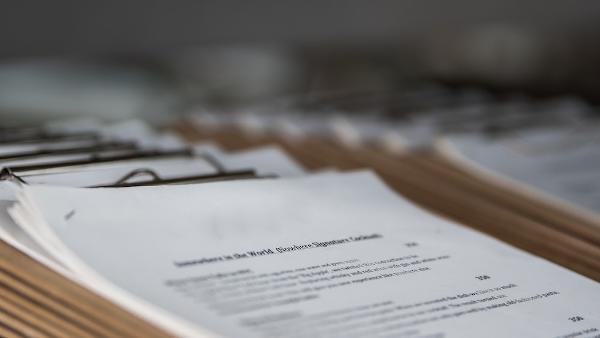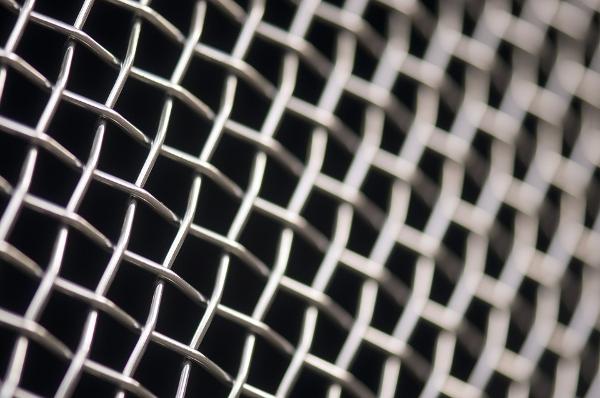FONTI FOSSILI | 38 ARTICOLI
In ottica di decarbonizzazione dei trasporti, i low carbon fuels, - ovvero biocarburanti liquidi (come biodiesel e HVO) e gassosi (come il biometano), o gli e-fuels (tipo l’idrogeno da elettrolisi) o i carbon fuels (carburanti da rifiuti plastici) – rivestono un ruolo molto importante, trattandosi in larga parte di soluzioni già adottate dal mercato e che già stanno dando buoni risultati.
La lotta ai cambiamenti climatici prende il via nel lontano 1992, con la prima Conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (Earth Summit) tenutasi a Rio de Janeiro, nel momento in cui venne istituita la “Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici” (UNFCCC). L’obiettivo, non vincolante, era quello di “ridurre le concentrazioni atmosferiche di emissioni GHG e prevenire interferenze antropogeniche pericolose con il sistema climatico terrestre”. La Convenzione entrò in vigore nel marzo del 1994 dopo la ratifica di 50 dei 154 Paesi aderenti ed aprì la strada alla prima “Conferenza delle Parti” (COP1), svoltasi a Berlino dal 28 febbraio al 7 aprile 1995, che si diede due anni di tempo per mettere a punto “una serie completa di azioni” coerenti con gli obiettivi di Rio.
Non si possono centrare gli obiettivi della decarbonizzazione senza passare dal gas. Tra le principali fonti del mix energetico globale, il gas naturale svolge e svolgerà ancora di più in futuro, con i gas verdi, un ruolo pivotale nel processo di transizione energetica, oltre ad essere indispensabile per garantire la sicurezza energetica dei sistemi nazionali. Per accompagnare questo processo serve però un’ulteriore spinta tecnologica, maggiori investimenti e una propensione politica che non abbia pregiudizi. Tutti temi che abbiamo trattato con Luigi Ciarrocchi, Presidente di Assorisorse.
Nella seconda metà del 2021, la crisi dei prezzi del gas naturale, tuttora in corso, ed il minore apporto delle fonti rinnovabili, in particolare nell’Europa settentrionale per l’eolico, hanno provocato una revisione sia del sentiment che degli scenari: definita come “un’iniezione di sano realismo” si è presa contezza che la traiettoria verso la piena decarbonizzazione implica rilevanti costi, che l’afflato ambientale deve prendere in considerazione la dimensione sociale e che al 2050, a tecnologia nota, le sole fonti rinnovabili non sembrano poter garantire la sicurezza necessaria dei sistemi energetici nei paesi europei. La discussione in corso sulla proposta della Commissione UE sulla tassonomia, ora includente anche il nucleare ed il gas naturale, ne sono uno degli esempi.
Qual è il futuro delle reti locali del gas nella transizione energetica? Per le sue dimensioni, il sistema di tubi, cabine e contatori che porta il metano nelle nostre case, uffici, ospedali e Pmi sarebbe a pieno titolo uno dei giganti tra le infrastrutture energetiche nazionali. Forse troppo frammentato per accorgersene, però, vive da tempo una fase di stagnazione e disorientamento, anche a causa della disattenzione del decisore pubblico, che sembra ricordarsi che esiste solo quando la cronaca ce lo costringe.
È ormai riconosciuto che le infrastrutture di trasporto di gas sono necessarie a supportare la transizione energetica; un processo che si protrarrà per alcuni decenni. La Direttiva 2021/0425 (COD) “on common rules for the internal markets in renewable and natural gases and in hydrogen” riconosce, infatti, che: “Gaseous fuels will play an important part in the energy mix by 2050, requiring the decarbonisation of the gas sector via a forward-looking design for competitive decarbonised gas markets”.
A che punto sono le gare per la distribuzione del gas? Dei 177 ambiti “ottimali”, al momento quelle svolte o avviate si contano sulle dita delle mani. Nella maggior parte del paese, sembra che non ci si scampo per sfuggire alla tirannia dello status quo. Del resto, tutto sembra disegnato per favorire l’inerzia: i gestori uscenti non hanno interesse alla contendibilità dei “loro” asset; molti comuni hanno partecipazioni nelle società incumbent; e molti altri, semplicemente, non vogliono perdere una leva indiretta di intervento diretto nell’economia attraverso assunzioni e forniture. La disciplina delle gare gas risale, nel suo impianto, al 1999.
Sino ad oggi il gas naturale ha rappresentato l’input energetico primario nel settore residenziale in Europa con una quota del 32% sui consumi finali di energia seguito dall’elettricità (25%), dalle fonti rinnovabili (20%), dai prodotti petroliferi (12%), dal calore derivato (8%) e dai combustibili solidi (3%). Più in particolare, nell’UE 27, il gas naturale costituisce il 69% dei consumi energetici del settore residenziale in Olanda, il 52% di quelli italiani, il 49% di quelli ungheresi, il 42% di quelli imputabili al settore residenziale in Belgio e il 39% di quelli tedeschi.
Nel momento in cui la pandemia ha allentato un po’ la sua presa, la domanda di energia ha ricominciato a correre. Secondo i dati dell’Agenzia internazionale per l’energia, nel 2021 a livello mondiale dovrebbe crescere del 4,6%, più che recuperando quanto perso nel 2020. Una stima ancora soggetta a qualche incertezza considerati i possibili effetti della cosiddetta variante “delta” ormai presente in oltre 120 Paesi nel mondo e già dominante in Europa, come hanno rilevato il Centro europeo prevenzione e controllo delle malattie (ECDC) e l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS).
I gestori dei sistemi di distribuzione, più spesso indicati come DSO (Distribution System Operators), sono responsabili delle reti di distribuzione e assicurano le forniture di acqua, elettricità, gas o altre commodities. In molti paesi, come l’Italia, le attività del DSO assolvono a una missione di servizio pubblico che garantisce ai cittadini il diritto di accesso all’energia. A seconda degli Stati, un DSO può essere responsabile di uno o vari tipi di rete.