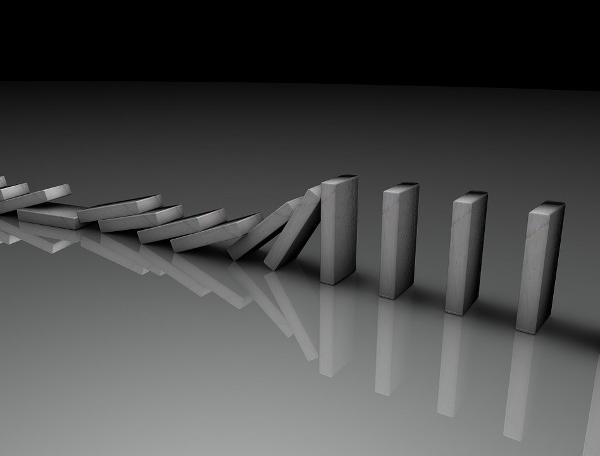Le cose non vanno come auspicato o previsto. Non vanno, in primo luogo, guardando alle emissioni clima-alteranti, il parametro cui si dovrebbe prestare maggiore attenzione, che anche nel 2023 sono aumentate, nonostante l’insoddisfacente andamento delle economie, la minor produzione di molte industrie, l’ulteriore progresso delle rinnovabili.
La Conferenza sul Clima di Sharm El-Sheikh si è chiusa ai tempi supplementari con l’accordo per istituire il Fondo Loss and Damage. In una decisione attesa da tre decenni, la COP27 ha deciso di istituire un nuovo strumento finanziario per sostenere la ricostruzione economica e sociale delle comunità povere e vulnerabili messe in ginocchio dai disastri climatici sempre più frequenti. Il Fondo potrà accedere a diverse fonti di finanziamento visto le considerevoli risorse finanziarie necessarie. Si stima che entro il 2030 siano necessari circa 290-580 miliardi di dollari aggiuntivi agli aiuti per l’adattamento.
La Cina non si tira indietro rispetto alle promesse fatte nel 2020: picco di emissioni e neutralità carbonica sono ancora rispettivamente gli obiettivi per il 2030 e il 2060. Ma la salita sembra più ripida di quanto immaginato e Xi chiarisce che si procederà con cautela, o meglio, in tandem: fin quando le fonti di energia rinnovabili non saranno in grado di garantire sicurezza e approvvigionamento stabile, Pechino non abbandonerà i combustibili fossili.
Un malcontento generale sta pervadendo la Francia da alcune settimane. La mobilitazione inizia nelle raffinerie: gli scioperi nel comparto mettono in ginocchio il paese a corto di carburante e con file chilometriche in tutti i distributori di benzina. Ma quel che è peggio è che il malcontento si sta estendendo ad altri settori professionali (centrali nucleari, trasporti) facendo tremare il governo Macron. Quale è la ragione alla base delle proteste? La risposta è chiara: molti francesi vedono il proprio potere d’acquisto ridursi a causa di un aumento generalizzato dei costi a cui non si riesce a far fronte, soprattutto nell’energia.
Non si può parlare di carbone, del rimbalzo dei suoi consumi senza contestualizzare il mercato a livello globale e senza soprattutto analizzare il ruolo del principale consumatore e produttore di questa fonte, la Cina. I numeri che ruotano intorno a questo paese, infatti, sono tali che una oscillazione al rialzo o al ribasso può avere ripercussioni importanti a livello internazionale. Ne abbiamo parlato con Corrado Clini Ex Ministro dell’Ambiente e oggi Visiting Professor presso la Tsinghua University School of Environment di Pechino
Nel novembre 2021, alla COP26 di Glasgow, l’Unione Europa si indignava di fronte alla proposta di Cina e India di modificare il testo finale, sostituendo il “phase out” del carbone con un più morbido “phase down”. Frans Timmermans, parlando subito dopo il ministro indiano, sottolineava come l’Unione Europea fosse pronta a spingersi ben oltre per porre fine all’uso del carbone e affermava “We know that coal has no future”, accompagnato da applausi scroscianti.
Il piano di contenimento dei consumi gas varato in settembre dal Mite prevede di ridurre la domanda di oltre un miliardo e mezzo di metri cubi tra agosto 2022 e marzo 2023, aumentando al massimo la produzione delle centrali a carbone. Una “massimizzazione” di fatto dell’utilizzo delle ultime centrali a combustibili solidi in Italia, del resto, era in gran parte già in atto da mesi per ragioni commerciali, tanto che l’entrata in vigore dell’obbligo non sembra aver modificato molto il quadro.
A partire dal 2016, il numero di operatori europei proprietari di centrali a carbone che hanno chiuso i loro impianti, o hanno annunciato piani di phase out al 2030, è salito a 171. E anche quest’anno, si sono aggiunti nuovi soggetti. A livello nazionale, diciassette paesi europei hanno smesso di bruciare carbone o si sono impegnati a farlo al più tardi entro il 2030 e nessun governo ha rinunciato a questa promessa.
La crisi in Ucraina ha determinato un crescente interesse per il commercio delle materie energetiche, dal petrolio al carbone passando per il gas naturale. Mentre il commercio intra europeo di petrolio e gas avviene, per lo più, tramite condotte, la maggioranza delle importazioni extra-europee avvengono via nave, così come la quasi totalità dell’import di carbone. Per tale motivo è importante determinarne il funzionamento e le principali criticità di mercato.
Il legame tra le navi e il traffico di materiale energetico è strettissimo, giacché per mare viaggia una quantità impressionante di questo genere di cargo. È molto il gas naturale quotidianamente imbarcato sulle cosiddette LNG carriers, sebbene i metri cubi che finiscono a bordo di queste navi siano una frazione contenuta del metano, propano, ecc. internazionalmente commerciato, trattandosi d’idrocarburi principalmente trasferiti via condotta. Come pure è moltissimo il carbon fossile spedito via mare. Siamo, infatti, in questo caso di fronte a un bene fondamentale per il funzionamento tanto del settore siderurgico, quanto degli impianti alimentati a vapore. E quest’ultimi sono tuttora parecchio diffusi. Particolarmente, in Asia, la quale è un’area largamente dipendente dalla lignite, dalla litantrace, ecc. recuperabile in Australia, in Sud Africa e in Russia.