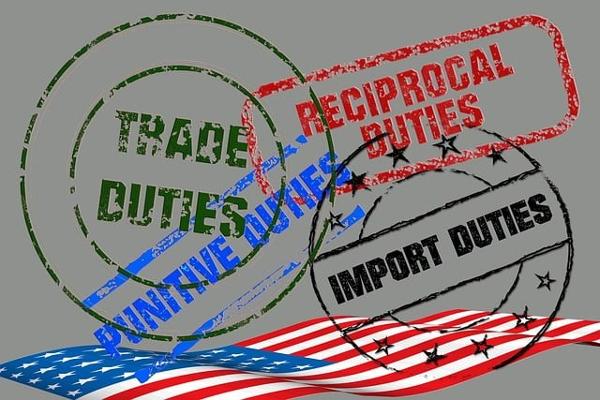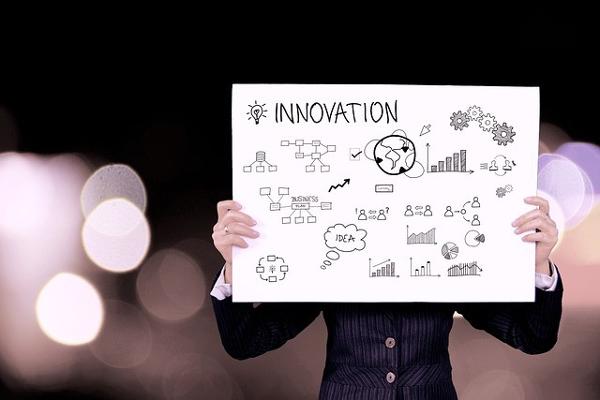MONDO ENERGIA | 150 ARTICOLI
La disponibilità di regolari e sufficienti approvvigionamenti energetici rappresenta un fattore chiave nel garantire la condizione di sicurezza energetica delle nazioni, considerata la rilevanza economico-strategica che l’energia riveste per lo sviluppo e la crescita economica degli stati.
As the Trump administration continues to roll out its sweeping tariff policy, the North American energy industry is working to address the effects of the President’s tariff strategy. The Trump administration intends to “unleash American energy,” (President Trump's America First Priorities – The White House) in part by imposing tariffs designed to remedy what the administration views as unfair trade practices and increase U.S. domestic energy production.
Con l’accordo, se così si può definire, tra UE e USA, siglato in Scozia lo scorso 28 aprile, si aggiunge un altro pezzo, l’ennesimo, a puzzle complicatissimo voluto dal Presidente Trump. Benché consapevoli delle difficoltà di fare un bilancio esaustivo degli impatti che queste scelte di politica commerciale avranno per gli attori coinvolti, è possibile però delinearne i primi contorni. Per RiEnergia, ci ha pensato Alessandro Fontana, Direttore Centro Studi Confindustria, in un’intervista puntuale che ci da l’istantanea di quello che è e quello che potrebbe essere.
Mentre l'amministrazione Trump porta avanti la sua stravagante politica tariffaria, l’industria energetica nordamericana sta lavorando per attutire le conseguenze di queste scelte. L’intenzione della nuova presidenza è quella di “liberare l'energia americana” (President Trump's America First Priorities - The White House), in parte imponendo dazi funzionali a rimediare a quelle pratiche commerciali considerate sleali e a incrementare la produzione energetica degli Stati Uniti.
Le transizioni tra le epoche storiche sono spesso difficili da cogliere mentre avvengono, tuttavia è opinione diffusa che stiamo assistendo alla fine di una fase della storia mondiale e all'alba di una successiva.
A definirla, da un lato, è il cambiamento della politica estera degli Stati Uniti, sempre più unilaterali e distanti dai loro alleati, scettici nei confronti delle istituzioni e degli accordi internazionali, sempre meno disposti a sopportare i fardelli della leadership internazionale.
Fanno discutere le ultime decisioni di Trump contro la Russia. Sono tanti gli osservatori internazionali che si stanno occupando del tema, mostrando non poche preoccupazioni per quelle che potrebbero essere le conseguenze sugli altri paesi.
È stato raggiunto un accordo tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea: a fronte della minaccia di dazi del 30% annunciata da Trump, Bruxelles ha accettato l’introduzione di dazi al 15% su una serie di esportazioni europee, con alcune eccezioni settoriali. In cambio, non verranno applicate ritorsioni. Un’intesa giudicata da molti deludente per l’Europa, soprattutto se confrontata con l’accordo ottenuto dal Regno Unito. Ma come si spiega questa scelta? È il frutto di una strategia negoziale sbagliata o di una valutazione più ampia dei costi politici ed economici interni?
Quello dei dazi è un tema centrale per l’amministrazione Trump, sia per il suo valore pratico, sia per il significato simbolico che gli è stato attribuito già in campagna elettorale. Negli intenti del Presidente, una aggressiva politica di dazi dovrebbe svolgere un ruolo importante nel rimettere in sesto i conti pubblici, portando capitali nelle casse dello Stato, favorendo il rientro del deficit commerciale, promuovendo il reshoring e aprendo ai beni e ai servizi statunitensi le porte di mercati cui questi hanno avuto, finora, un accesso limitato.
Throughout history, innovation has delivered advancements that shape how we produce, use and transmit energy around the world. From the creation of the first steam engine in the 17th century and the electric battery 100 years later, to the development of the wide portfolio of modern energy technologies we use today – gas turbines, nuclear reactors, high voltage power lines, motors, and so much more – energy innovation has been a key driver of progress.
Tecnologie digitali, intelligenza artificiale, internet of Things, machine learning: il mondo dell’energia corre veloce e stargli al passo è importante quanto necessario in ottica di decarbonizzazione e riduzione della dipendenza energetica. La rivoluzione energetica e digitale è ormai partita e servono investimenti sia nei mezzi ma soprattutto nelle persone. Di questi temi RiEnergia ha parlato con il Professore Massimo La Scala, ordinario di sistemi elettrici per l’energia presso il Politecnico di Bari e Direttore (per il Politecnico di Bari) del master di II livello in “Innovazione nei Sistemi Elettrici per l’Energia.