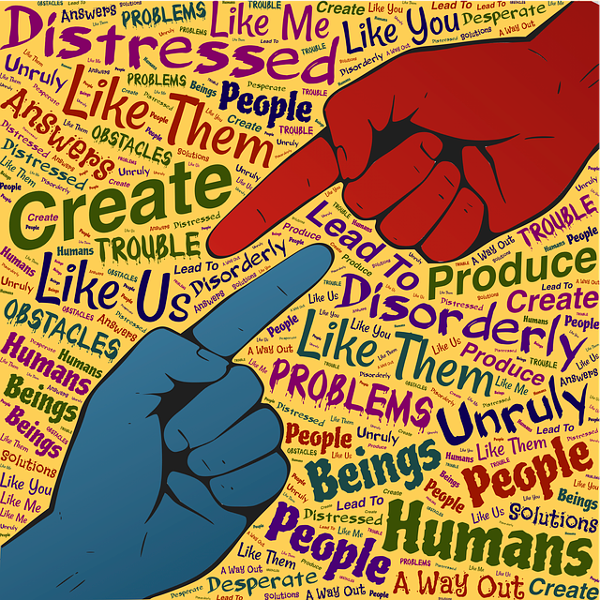Due dati sono indiscutibili. Nel 2024, la Germania ha prodotto circa il 61,5% dell'energia elettrica con fonti rinnovabili, la Spagna quasi il 60%, mentre in Italia siamo circa al 41%. Tra i grandi paesi europei solo in Francia, dove domina il nucleare, la percentuale (26,3%) è minore di quella italiana.
Parafrasando una celebre frase del romanzo di George Orwell, “La fattoria degli animali”, tutti i sistemi di accumulo sono eguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Ad esempio, in Italia la capacità di accumulo di energia a livello di rete è in crescita, con una potenza installata di 5,56 GW e una capacità di 12,94 GWh al 31 dicembre 2024. La maggior parte di questa capacità è però abbinata a impianti fotovoltaici (9,05 GWh, pari al 70% della capacità totale) ed è pertanto destinata a svolgere essenzialmente la funzione di power shifting.
Dai dati forniti dal GSE nel “Rapporto statistico 2023 sul solare fotovoltaico” risulta che gli impiantì con potenza superiore a 1 MW, per la maggior parte presumibilmente installati a terra, erano 1.360 nel 2022 e 1.664 nel 2023. In un solo anno se ne sono aggiunti 304. Poiché in totale a fine 2023 erano in esercizio 1.597.447 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a 30.319 MW, senza alcun dubbio le installazioni fotovoltaiche hanno modificato il panorama italiano.
Il limitato contributo previsto per gran parte delle misure di decarbonizzazione più efficaci è Il filo rosso che lega la versione aggiornata del Pniec. Nel 2030 sono, infatti, superiori ai target europei sia i consumi di energia primaria (123 vs. 111 Mtep), sia quelli di energia finale (102 vs. 93 Mtep).
Come spesso accade per le scelte demagogiche, anche la decisione di garantire un prezzo all’ingrosso del kWh identico per tutto il territorio nazionale (PUN) è costata cara ai consumatori italiani. In due articoli sulla Staffetta Quotidiana (Rivisitare la governance elettrica, Gli struzzi di San Filippo del Mela) ne ho quantificato il costo annuale dovuto alle molteplici opposizioni che in Sicilia hanno ritardato la realizzazione del collegamento AT Sorgente -Rizziconi con la penisola: variabile tra 400 e 600 milioni di euro, secondo l’andamento dei prezzi del kWh.
Secondo il rapporto Ember “Electricity Review 2023”, globalmente*, nel 2022 tra le rinnovabili la produzione idroelettrica occupava ancora il primo posto con 4.311 TWh (15% del mix produttivo globale), seguita dall’eolica (2.160 TWh, 7,6%), dalla fotovoltaica (1.284 TWh, 4,5% dalle bioenergie (672 TWh, 2,4%), con le altre rinnovabili allo 0,4%, e con il 61% ancora coperto da combustibili fossili. Nello stesso anno, però, si è registrata una crescita record della generazione fotovoltaica ed eolica, il cui contributo complessivo è salito al 12% dal 10% dell’anno precedente.
In USA viene varato l’Inflation Reduction Act (IRA), un piano di 369 miliardi di dollari, che finanzia gli investimenti industriali nei settori dell'energia pulita (in particolare produzione di veicoli elettrici, batterie, pannelli solari, turbine eoliche) e riserva i crediti d’imposta a chi acquista prodotti green realizzati negli Stati Uniti.
La Commissione Europea risponde con Il Green Deal Industrial Plan, presentato al forum economico di Davos dalla Presidente von der Leyen. Il Piano sarà articolato in due provvedimenti: il Net-Zero Industry Act e il Critical Raw Materials Act. In entrambi i casi sono previste misure finalizzate a rendere competitivi gli investimenti industriali in produzioni coerenti con gli obiettivi europei di decarbonizzazione.
Nelle 14 pagine di testo del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, l’unico obiettivo strutturale citato è la riduzione in modo permanente della domanda grazie a un incremento annuale di circa 8 GW degli impianti a fonti rinnovabili, incremento che andrà a regime nel 2023. Si tratta però di un target irrealizzabile. Benché tassativamente previsto entro giugno, non è stato ancora emanato il decreto dallo stesso MiTE, con i criteri che le Regioni dovranno seguire per individuare le aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili. Dopodiché, le Regioni avranno a disposizione sei mesi per definire la mappa.
Qualsiasi guerra richiede interventi eccezionali degli stati nella gestione dell’economia. Circostanza che a maggior ragione si sta verificando oggi in presenza di una guerra “ibrida”(così definita nel convegno “Energia Italia 2022”) che si sta svolgendo su tre fronti - Ucraina, prezzi delle materie prime, sicurezza degli approvvigionamenti - accomunati dalla medesima causa scatenante: negli ultimi decenni i rapporti delle nazioni europee con paesi al di fuori dell’Ue sono stati dettati da interessi essenzialmente mercantili, sottovalutando le implicazioni geopolitiche di questa scelta.
Nonostante gli effetti devastanti del Covid-19 sull’economia, sia diretti (lockdown) che indiretti, il 2020 ha globalmente registrato un ulteriore record nella stipula di PPA. Secondo i dati resi noti da Bloomberg: 23,7 GW, con incremento del 17,9% sul 2019 (20,1 GW). Un risultato oltre tutto conseguito malgrado il robusto calo dell’apporto del continente americano: 13,6 GW contro i 16,3 GW dell’anno precedente, su cui ha soprattutto pesato la diminuzione dei PPA stipulati negli Stati Uniti (11,9 GW), che erano i tradizionali motori della loro crescita.