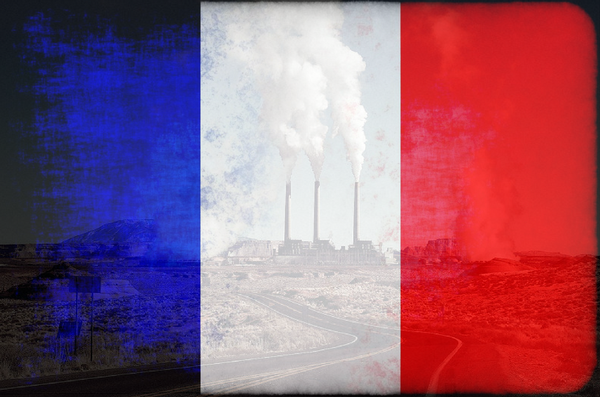FONTI FOSSILI | 60 ARTICOLI
La transizione energetica tedesca - “Energiewende” - è internazionalmente riconosciuta come uno sforzo rivoluzionario per avviare una trasformazione low-carbon in una delle principali economie industrializzate. In Germania, la crescita della capacità rinnovabile è stata significativa, con una quota di FER nel mix elettrico che ha raggiunto, nei primi sei mesi del 2018, oltre il 40%. Tuttavia, l’energia rinnovabile ha in gran parte sostituito quella nucleare, il cui phase out completo è atteso entro il 2023.
Negli ultimi decenni, la produzione e il consumo di carbone sono diminuiti in misura consistente in Polonia. Tuttavia, nonostante questa impressionante evoluzione, il paese è ancora lontano dall’eliminazione o anche solo da una drastica riduzione di questa fonte dal suo mix energetico. Alla base di questa considerazione, diversi fattori quali: la tradizione carbonifera del paese, aspetti socio-politici, questioni di sicurezza energetica.
Il carbone è stato per lungo tempo una parte importante del mix di generazione del Regno Unito, fornendo negli ultimi due decenni un terzo dell’energia elettrica nazionale. Oggi la situazione è molto diversa al punto tale che, nel II trimestre 2018, il carbone ha rappresentato solo l'1,3% di tutta l’elettricità prodotta in UK. Inoltre, durante l’estate, vi sono stati giorni in cui nessuna centrale a carbone era in funzione. Come siamo arrivati fino a qui?
Nel 2018, si può dire che la storia carbonifera della Francia sia prossima alla fine.
Dai 23 milioni di tonnellate (Mt) del 2000, il consumo è sceso a 14 mt nel 2017, pari al 3,6% della domanda di energia primaria del paese. Poco meno della metà (45%) di questo volume è stato assorbito dalle ultime tre cokerie esistenti: Dunkerque (Nord-Passo di Calais), Seremange (Mosella) e Fos-sur-Mer (Bocche del Rodano).
L’energia è da sempre un fattore abilitante dello sviluppo. Oggi, in particolare, in un momento storico di transizione verso economie decarbonizzate e di crescente elettrificazione dei consumi, la qualità e l’efficienza della crescita dell’Italia, al pari di ogni Paese, non possono essere dissociate dalla qualità e dall’efficienza del suo sistema energetico, in primis quello elettrico. In questo contesto, la possibilità di disporre di energia elettrica a prezzi competitivi è un fattore fondamentale per sostenere le dinamiche macro-economiche del Paese. Tra gennaio e luglio 2018 il prezzo dell’energia elettrica è cresciuto con un tasso medio mensile del 4,2%
La produzione di elettricità, sostanzialmente a partire dal Dopoguerra, è stata resa possibile soprattutto grazie allo sfruttamento delle risorse di origine fossile (petrolio, gas e carbone) che hanno alimentato le grandi centrali termoelettriche fino ai giorni nostri. Il carbone, in maniera particolare, ha giocato un ruolo da protagonista nell’elettrificazione del pianeta, grazie alla facilità di trasporto e al costo relativamente contenuto rispetto ad altre fonti. Il rovescio della medaglia, di cui tuttavia si è preso coscienza troppo tardi, è che questa modalità di produzione elettrica ha un costo decisamente troppo elevato in termini di emissioni inquinanti.
Per parafrasare Roberto Benigni in “Johnny Stecchino”, Roma ha una piaga terribile: il traffico. Tutti i sindaci che sono saliti al Campidoglio si sono trovati alle prese con la congestione delle strade della Capitale, disegnate per accogliere bighe e lettighe, ma un po’ meno adatte a pullman e tir. Tra divieti alla circolazione e domeniche ecologiche, la Sindaca Raggi, però, si è sforzata di superare in ambizione tutti i suoi predecessori.
La sentenza del tribunale amministrativo federale di Lipsia del 27 febbraio 2018, che ha sancito la possibilità per le città tedesche di ricorrere alla misura del divieto di circolazione per le auto a diesel, ha risuonato in Germania e in tutto il mondo come la campana a morto del motore diesel, incolpato di appartenere ad un mondo antiquato e di essere la causa principale di livelli eccessivi di inquinamento nelle città e nelle aree metropolitane.
A livello internazionale, il GNL (Gas Naturale Liquefatto) è una realtà consolidata e in alcune aree del mondo – ad esempio Giappone, Australia, USA- è una risorsa in continua espansione, sia in termini di capacità di liquefazione che di importazione.
Anche nell’Unione Europea, l’utilizzo del gas naturale in questa forma si sta recentemente affermando per ragioni di economicità, con le dinamiche mondiali dei prezzi che rendono accessibile questo vettore energetico;
Il gas si conferma la principale fonte per l’uso riscaldamento, tanto in Italia quanto in Europa. Se nel nostro paese, o più in generale nel Vecchio Continente, la scelta è prevalentemente di natura tecnologica e/o economica, altrove il tema assume anche una dimensione sociale. Nei paesi in via di sviluppo, infatti, il numero di persone prive di accesso a servizi energetici moderni è ancora molto elevato e negli anni a venire il gas – insieme a GPL, elettricità e nuove rinnovabili – potrebbe assumere un ruolo determinante nella riduzione della povertà energetica.