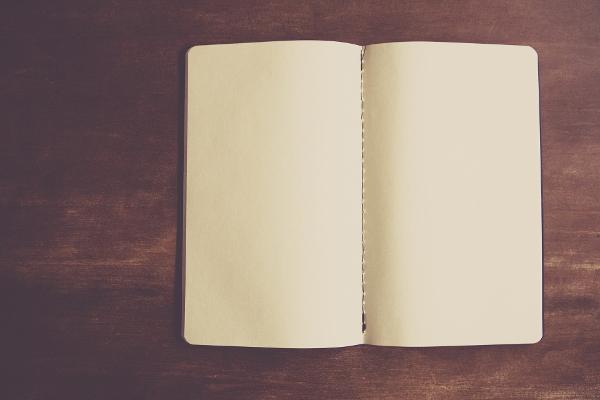Azienda cooperativa di trasformazione agroindustriale fondata ad Alfonsine (RA) nel 1994, Fruttagel lavora ogni anno oltre 120 mila tonnellate di prodotti ortofrutticoli, di cui il 24% circa biologici certificati, in larga parte conferiti dai propri soci. L’azienda produce bevande a base di frutta e di legumi/cereali, derivati del pomodoro e ortaggi surgelati nei suoi due stabilimenti di Alfonsine e Larino (CB), seguendo tutte le tutte le fasi della filiera, dal campo alla tavola. I prodotti Fruttagel arrivano al consumatore attraverso i canali retail (GD, DO, Indipendente), i servizi di ristorazione collettiva e commerciale, il food service, l’industria e il porta a porta, sia con marchi propri – tra cui Almaverde Bio, Consorzio di cui Fruttagel è socio fondatore – sia con referenze a marchio dei distributori.
Camst è una azienda di ristorazione e di facility services nata a Bologna nel 1945 e oggi presente in tutta Italia e in alcuni Paesi europei (Danimarca, Germania, Spagna e Svizzera) attraverso Camst group. L’impegno nei confronti delle persone e la volontà di crescere in modo sostenibile hanno caratterizzato lo sviluppo della cooperativa nei suoi 75 anni di storia. È in questa ottica che l’azienda ha scelto di aderire all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile, un piano di azione globale che definisce 17 obiettivi da raggiungere per affrontare le grandi sfide del pianeta Terra.
Dall'inizio del 2020 stiamo vivendo un paradosso planetario che potremmo definire socio-ambientale. Da un lato, il mondo viene sconvolto dalla più grave pandemia degli ultimi 100 anni, che sta mettendo in evidenza le vulnerabilità della struttura socio-economica della società in cui viviamo: centinaia di migliaia di decessi; milioni di contagiati; sistemi sanitari al collasso; crisi economiche senza precedenti; distanziamento sociale estremo.
L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare. Il 22 marzo si è celebrata la giornata mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Entro il 2040, nel mondo, circa 1 bambino su 4 vivrà in zone con uno stress idrico estremamente elevato. Oggi sono quasi 160 milioni i bambini che vivono in zone ad alta o estrema siccità. Più di 3,5 miliardi di persone - circa la metà della popolazione mondiale - soffrono di grave penuria idrica per almeno un mese all'anno, di cui circa 2 miliardi per almeno sei mesi all'anno. Inoltre, sono circa 500 milioni i bambini che vivono in zone ad altissimo rischio di inondazioni a causa di eventi meteorologici estremi come cicloni, uragani, tempeste e innalzamento del livello del mare. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di dedicare la Giornata Mondiale dell’Acqua, che si è celebrata lo scorso 22 marzo, a tutti i bambini del mondo: perché dobbiamo ricordarci, ogni giorno, di garantire loro il futuro che meritano.
In occasione della recente “Giornata mondiale dell'acqua” e alla luce dell’emergenza-coronavirus, Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale leader nella lotta alla fame e alla malnutrizione, ha ribadito la centralità dell’utilizzo di acqua pulita e potabile da parte di tutti. Senza accesso a risorse idriche adeguate, non è possibile garantire l’igiene. E laddove non c’è igiene, si registra inevitabilmente un tasso più elevato di malattie. Basti pensare che la malnutrizione, per 1 bambino su 2, è ancora collegata alle cosiddette “malattie dell’acqua”.
Il modo in cui l’Africa soddisferà le necessità energetiche di una popolazione in forte crescita e sempre più urbanizzata sarà cruciale non solo per l’economia e lo sviluppo energetico del continente ma del mondo intero. Tra oggi e il 2040 metà dell’aumento della popolazione mondiale avverrà in Africa ed entro il 2023 la popolazione africana sorpasserà quella della Cina e dell’India fino a raggiungere 2 miliardi di persone prima del 2040. Nello stesso arco temporale più di mezzo miliardo di persone si andranno ad aggiungere alla popolazione urbana del continente, la più grande urbanizzazione mai vista della storia dell’umanità.
Secondo le previsioni del Dipartimento Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UNDESA), il continente africano contribuirà a più della metà della crescita della popolazione mondiale tra il 2019 e il 2050. Il miliardo di africani che vivono a sud del deserto del Sahara duplicherà e le zone urbane assorbiranno verosimilmente gran parte del boom demografico, ponendo un serio problema non solo d’ordine sociale ma anche e soprattutto di carattere economico.
La nostra dieta, insieme all’articolata industria agroalimentare che la sostiene, ha un impatto imponente sull’ambiente in termini di risorse naturali consumate e di contributo al riscaldamento globale. Secondo il rapporto speciale prodotto dall’Ipcc su cambiamenti climatici e uso del suolo, circa il 23% delle emissioni di gas serra di origine umana proviene da agricoltura, silvicoltura e altri usi del suolo; l’agricoltura, inoltre, è responsabile di circa la metà delle emissioni di metano indotte dall’uomo ed è la principale fonte di protossido di azoto, due gas serra molto potenti.
Tracciare nuove traiettorie di futuro per il continente africano, capaci di creare sviluppo nelle aree più depresse del pianeta e dare un’alternativa alle popolazioni rispetto alla dolorosa scelta di lasciare le proprie terre e finire spesso preda dei trafficanti di essere umani. E’ l’obiettivo del primo progetto agricolo italiano di filiera nel continente africano, sottoscritto dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini, la più grande organizzazione agricola a livello italiano ed europeo, Claudio Descalzi amministratore delegato dell’Eni, Società integrata nell’energia impegnata nella promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, Federico Vecchioni amministratore delegato Bonifiche Ferraresi (BF) Spa, la più grande azienda agricola italiana e unico gruppo agro industriale quotato in borsa, e CAI, i Consorzi Agrari d’Italia.