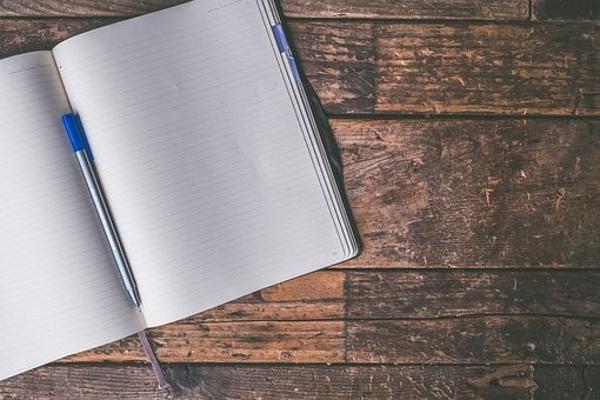La Commissione Europea mira ad abbattere le emissioni di gas serra entro il 2050, con l’obiettivo intermedio di ridurle almeno del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Tali obiettivi, come stabilito dalla European Climate Law, saranno raggiunti attraverso l’adozione di strategie che mirano alla riduzione delle emissioni, all’aumento degli investimenti in tecnologie verdi e alla protezione dell’ambiente naturale.
Traditionally, when an oil and gas field production cycle end and all usable hydrocarbons have been extracted, the top side facilities are dismantled, the wellbore is permanently plugged and abandoned, and the surrounding land or seabed is returned to its natural condition. In the UK Continental Shelf (UKCS) alone, it is forecast that 1,211 wells across 230 fields will be decommissioned between 2019 to 2028. The current projected decommissioning costs for the UKCS total $60 billion with efforts underway to reduce that figure to $51 billion by the end of 2022.
Tradizionalmente, nel settore Oil&Gas, quando il ciclo produttivo si conclude e tutte le risorse utilizzabili di idrocarburi sono state estratte, gli impianti in superficie vengono dismessi, il pozzo viene definitivamente chiuso, mentre le aree adiacenti vengono riportate alle loro condizioni naturali. Soltanto nella piattaforma continentale del Regno Unito, saranno circa 1.211 i pozzi, suddivisi tra 230 giacimenti, che verranno dismessi entro il 2028. I costi stimati per queste operazioni sono di circa 60 miliardi di dollari, ma l’obiettivo è quello di contenere la spesa a 51 miliardi di dollari.
Northern Lights costituisce il segmento di trasporto e stoccaggio dell’anidride carbonica in seno al progetto Longship, primo al mondo ad integrare tutta la catena del valore della CCS su scala industriale. Il progetto, in fase avanzata e per cui sono stati conclusi già accordi internazionali con emettitori importanti, costituisce un best case nel panorama europeo che fa ben sperare per una maggiore diffusione della tecnologia di cattura e stoccaggio della CO2, ormai da più parti considerata come fondamentale per raggiungere gli obiettivi ambiziosi della net zero carbon. Di questo progetto, ma anche, più in generale, di questa tecnologia ne abbiamo discusso con la Dottoressa Renata Meneguolo, principal geologist del progetto Northern Lights.
Cosa motiva e spinge le persone a costituire una comunità energetica, al di là della questione economica, che esiste e che certamente non può essere sottaciuta? La questione che mi è stata posta, non solo è quanto mai attuale ma è il crinale sul quale si gioca la capacità della pubblica amministrazione e del privato di offrire soluzioni che i cittadini possano percepire non come qualcosa di imposto dall’alto, ma che li veda protagonisti e artefici del loro destino e di quella di una intera comunità.
Nel dicembre 2019, la Commissione europea ha presentato l'European Green Deal, il piano per rendere l'Europa neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Come passaggio intermedio (Fit for 55), l'UE ha alzato la sua ambizione climatica per il 2030, impegnandosi a ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030. L'UE aspira a diventare il primo continente a rimuovere dall'atmosfera almeno la stessa quantità di CO2 che produce entro il 2050! Secondo l'ultimo rapporto dell'IPCC (Intergovernmental panel on climate change) è molto più economico tagliare le emissioni subito, utilizzando le rinnovabili invece di carbone, gas e petrolio, piuttosto che rimuoverle successivamente.
Transizione ecologico/energetica, contenimento degli effetti antropici sull’ambiente, responsabilizzazione individuale e collettiva rispetto al cambiamento necessario, inclusione, riduzione della dipendenza dall’estero delle fonti energetiche, rendono sempre più importante definire un processo in cui il consumatore finale di energia svolga un ruolo sempre più attivo nei processi di cambiamento.
La transizione del sistema energetico da un modello prevalentemente basato su fonti fossili a un modello basato su fonti rinnovabili prosegue inesorabile con tassi di crescita annuali globali dell'ordine del 30% per il fotovoltaico e del 15% per l'eolico. Siamo nel pieno di una prolungata crescita esponenziale, con tempi di raddoppio del mercato che sono di due anni e mezzo per il fotovoltaico e di cinque anni per l'eolico: in dieci anni il mercato del fotovoltaico si moltiplica per dodici volte, l'eolico per quattro.
Il ritmo di avanzamento delle tecnologie digitali si conferma il più rapido della storia se confrontato con qualsiasi altra innovazione. Oggi, le tecnologie basate sui dati dominano il modo in cui viviamo, apprendiamo, viaggiamo e interagiamo tra di noi. Anche il sistema energetico segue questa strada e accoglie i vantaggi offerti dalla digitalizzazione. La trasformazione digitale contribuisce alla decarbonizzazione dell’approvvigionamento energetico, affrontando la questione della dipendenza dai combustibili fossili e promuovendo la diffusione e l’integrazione di fonti di energia rinnovabile nel sistema energetico, rafforzandone al contempo la resilienza.
I recenti sviluppi geopolitici e geoeconomici stanno significativamente influenzando l’evoluzione del settore Oil&Gas, con particolare riguardo al comparto del gas naturale, che già da diversi anni ha visto crescere la sua rilevanza a livello globale e nei mix energetici di diversi Paesi, andando progressivamente a spodestare sua maestà il petrolio.
Allo stesso tempo, le numerose scoperte di giacimenti di gas naturale, unite alle innovazioni tecnologiche che hanno reso possibile una più ampia ed economica commercializzazione di questa risorsa,