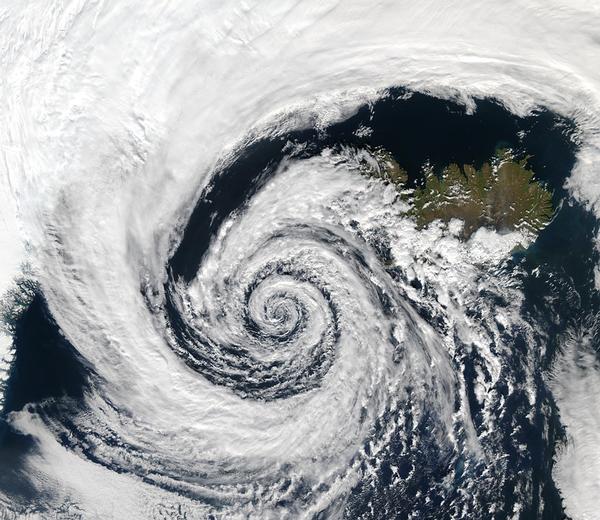ACQUA & AMBIENTE | 146 ARTICOLI
L’inquinamento dell’aria nelle nostre città continua a fare vittime, e non poche, nonostante i miglioramenti registrati in molte aree del mondo, a cominciare dall’Europa. Numeri che portano a considerare questo fenomeno una vera e propria pandemia, come è stata chiamata nella ricerca della Fondazione per lo sviluppo sostenibile presentata da meno di un mese “La sfida della qualità dell’aria”. Nel mondo ogni anno milioni di persone muoiono a causa dell’inquinamento atmosferico e 9 persone su 10 vivono in luoghi con livelli di inquinamento più alti di quelli raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In Europa i tre inquinanti a maggiore criticità – particolato atmosferico, biossido di azoto e ozono – annualmente sono responsabili di oltre mezzo milione di decessi prematuri, più di 20 volte il numero delle vittime di incidenti stradali.
Nell’Unione Europea, il crescente consumo di biomassa per il riscaldamento degli ambienti domestici – ma più in generale anche per la produzione di energia - è ascrivibile sia a politiche di risposta al cambiamento climatico che favoriscono il ricorso a fonti di energia rinnovabile che, in alcuni casi, a ragioni di convenienza economica, specie laddove si rilevano condizioni di povertà energetica e la materia prima può essere raccolta a livello locale. Tuttavia, questo aumentato e crescente utilizzo è fonte di preoccupazione per via del rilevante contributo della biomassa alle emissioni di particolato (PM -Particulate Matter) rilasciate durante la combustione e ritenute pericolose per la salute umana.
Il gas si conferma la principale fonte per l’uso riscaldamento, tanto in Italia quanto in Europa. Se nel nostro paese, o più in generale nel Vecchio Continente, la scelta è prevalentemente di natura tecnologica e/o economica, altrove il tema assume anche una dimensione sociale. Nei paesi in via di sviluppo, infatti, il numero di persone prive di accesso a servizi energetici moderni è ancora molto elevato e negli anni a venire il gas – insieme a GPL, elettricità e nuove rinnovabili – potrebbe assumere un ruolo determinante nella riduzione della povertà energetica.
Secondo i risultati del recente studio Innovhub, è stato confermato l’impatto negativo in termini ambientali e sanitari degli impianti alimentati a biomassa legnosa per l’utilizzo nel settore del riscaldamento, a fronte di performance positive dei combustibili gassosi. Il riscaldamento a gas è quindi la soluzione migliore per le famiglie italiane?
Lo studio di Innovhub presentato a Milano il 23 ottobre ha ulteriormente indicato con dati tecnici alla mano il forte contributo negativo delle biomasse all’inquinamento atmosferico, con i conseguenti danni per la salute umana.
Il processo di decarbonizzazione sul territorio europeo è imprescindibile dalle regolamentazioni relative al sistema ETS (Emission Trading Scheme), il cui obiettivo principale è incentivare la riconversione degli impianti industriali dell’eurozona verso fonti energetiche a minore intensità di carbonio. In estrema sintesi, questo sistema cap-and-trade fissa un tetto massimo alle emissioni annuali consentite e, qualora un determinato impianto inquini più di quanto gli venga concesso, dovrà compensare questo squilibrio investendo nella produzione pulita degli impianti più virtuosi (concretamente acquistandone i permessi di emissione di questi ultimi, che ne avranno in eccedenza, avendo emesso meno di quanto per loro stabilito).
Il G7 sull’Ambiente si è svolto dopo la decisione di Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul clima. Si tratta di una decisione che ha portata storica e che, inevitabilmente, ha proiettato un’ombra sinistra sul G7 di Bologna, ridimensionandone la valenza. Con monotona circolarità, la storia si ripete: Trump sta all’accordo di Parigi come George W. Bush sta al Protocollo di Kyoto. Entrambi rifiutano un accordo che la comunità internazionale reputa epocale per la lotta al cambiamento climatico: eccessivo lo sforzo per la maggiore potenza del mondo, iniqua la distribuzione dei tagli.
La decisione del Presidente Trump di far uscire gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi è stata deludente, se non inaspettata, per molti leader di governo, uomini d’affari e cittadini statunitensi impegnati nella lotta al cambiamento climatico. Si ricorda infatti che la leadership USA fu cruciale durante le fasi negoziali dell’Accordo. Tuttavia, anche se il ritiro degli Stati Uniti costituirà una perdita, non rappresenterà la fine dell’innovazione e dei progressi degli USA in materia di clima.
Di seguito sei ragioni per rimanere ottimisti:
La decisione di Trump riguardo l’accordo di Parigi ha scatenato sui media reazioni contraddistinte da un livello di disinformazione inimmaginabile. Viene dato per scontato che il riscaldamento della Terra di circa 1°C dal 1750 ad ora sia quasi totalmente imputabile alle emissioni di CO2 conseguenti l’uso dei combustibili fossili, ipotesi nota come Anthropogenic Global Warming- AGW. Si confondono inquinanti e gas serra e si afferma che i cosiddetti fenomeni estremi siano aumentati di intensità e di frequenza in questi ultimi decenni. Basterebbe il riferimento ai rapporti dell’IPCC, ente pur certamente propenso all’ipotesi AGW, per sconfessare queste asserzioni.
La ricerca scientifica sul clima fatica a trovare spazio sui media destinati al grande pubblico. In questo quadro, quale è stato il ruolo svolto dall’IPCC?
Sappiamo che i media faticano a dare spazio al tema dei cambiamenti climatici, che deve necessariamente fare i conti con la concorrenza di notizie ritenute più attraenti e sensazionali, in grado di suscitare maggior interesse dei lettori e degli utenti. Si rischia quindi di parlare di clima in poche occasioni, spesso collegate ad eventi contingenti: nel caso di eventi climatici estremi da una parte e di grandi eventi internazionali sul tema dall’altro.
La bozza di Strategia Energetica Nazionale (SEN) recentemente presentata dal MiSE e dal MATTM, come era prevedibile, è fortemente raccordata con gli obiettivi che l’Europa si è data al 2030 con il Piano Clima Energia nell’ambito dell’Unione per l’Energia, in termini di riduzione di CO2, percentuale di impiego di fonti rinnovabili e riduzione del consumo grazie a misure di efficienza energetica.
In particolare, per quanto riguarda la riduzione di CO2, il Piano fissa uno specifico obiettivo sia sulle emissioni dei settori ETS (-43% rispetto al 2005) sia sulle emissioni del non-ETS (-30%).