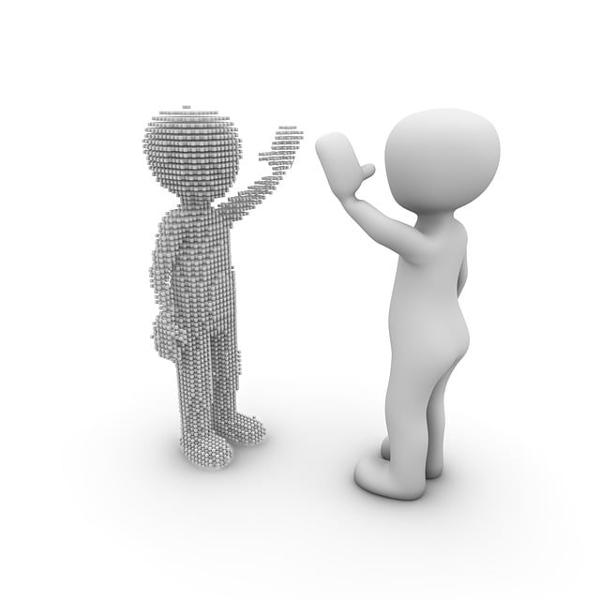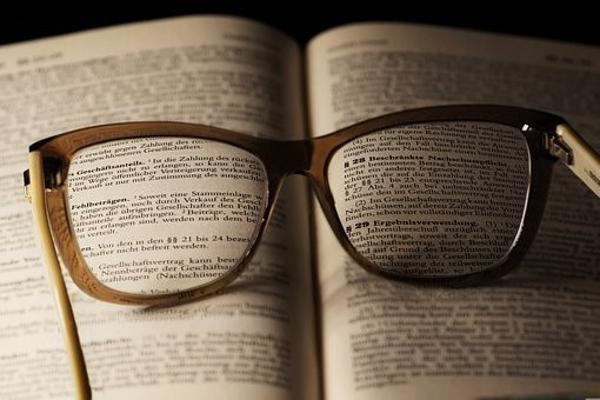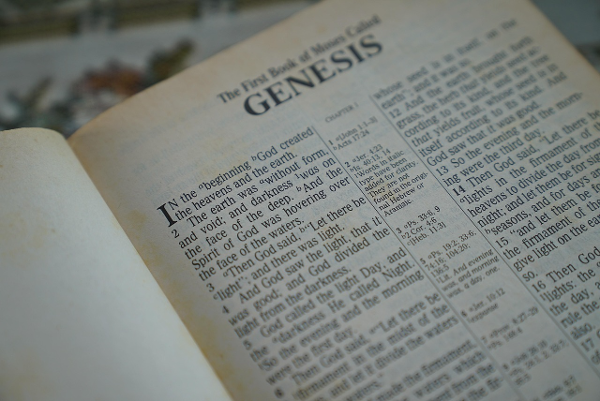Che ne sarà del 2026? In che modo cambierà il panorama energetico? Ci saranno novità in grado di immettere il mondo dell'energia su sentieri nuovi? Queste domande, certo, sono ingenue perché l'energia è un fenomeno che evolve nel lungo periodo e quindi è irrealistico aspettarsi cambiamenti significativi da un anno all’altro.
Nel settembre 2023 destò un certo scalpore un articolo del Direttore Esecutivo della IEA Fatih Birol, apparso sul Financial Times, che annunciava il contestuale declino della domanda di petrolio, carbone e gas prima del 2030. I commenti erano rimbalzati nei media del villaggio globale annunciando, con enfasi, la fine dell'era dei fossili.
Non è esagerato dire che l'enciclica di Papa Francesco Laudato Sì sia la Rerum novarum del 21° secolo. Così come nel 1891 Papa Leone XIII ha aperto la via all’approfondimento dei temi sociali da parte della Chiesa, nel 2015 Papa Francesco ha messo al centro della riflessione della Chiesa, per la prima volta nella sua storia, la questione ambientale, in particolare la sua dimensione climatica. L’enciclica precede di qualche mese il Paris Agreement che rappresenta, oggi, l'architettura istituzionale di riferimento delle politiche climatiche dei paesi.
Il 2025 sarà, tra tante altre cose, l’anno di un anniversario: infatti, duecento anni fa, nel 1825, venne inaugurato in Inghilterra il primo treno commerciale della storia tra Stockton-on-Tees e Darlington. In questi due secoli, il genere umano ha intrapreso un sentiero di crescita economica straordinaria, mai esperito in precedenza.
Nell'eterno ritorno dei temi immortali delle COP - la messa al bando dei combustibili fossili, mai più centrali a carbone, fondi ai paesi poveri per sostenere la mitigazione e l'adattamento, target più ambiziosi, stop ai sussidi per i fossili, crediti di carbonio, deadline di vario genere - due sembrano essere stati quelli rilevanti nella conferenza di Baku.
Dove stiamo andando? Il 2024 rappresenterà un punto di rottura? Ci immetterà su un sentiero nuovo della transizione energetica? Porsi domande del genere potrebbe apparire retorico ma non lo è. Con il 2024, infatti, ci avviciniamo al punto centrale del decennio critico, quel 2020-2030 così importante poiché diverse istituzioni hanno formalmente espresso obiettivi da raggiungere nel 2030.
Periodicamente, la questione dei sussidi energetici torna sulle pagine dei giornali e infiamma il dibattito. Un recente report del Fondo Monetario Internazionale evidenzia come nel 2022 i sussidi ai combustibili fossili abbiano raggiunto la ragguardevole cifra di 7 trilioni di dollari. Non solo la cifra rappresenta il 7,1% del PIL mondiale, ma essa è aumentata di ben due trilioni rispetto al 2020, ovvero di quasi il 30%.
Attenuata dalla distanza e dalla ripetitività, la voce del G7 ha lambito le orecchie della società civile che, distratta, si è girata dall’altra parte. Troppo fiacca per suscitare interesse. Più che una voce, un’eco. Di cosa? Dei vertici inflazionati dei potenti, dei meeting ricorrenti in questa o quell’amena località dell’Occidente o dell’Oriente, dei precedenti G7, centri di negoziazione e di dibattito da cui, periodicamente, emanano tenui dichiarazioni difficilmente distinguibili l’una dall’altra.
Monocorde, il tempo avanza. Gli anni si consumano e il budget carbonico compatibile con 1,5°C diventa sempre più sottile. Le COP sono periodici fiocchi di neve che si depositano sul tappeto logoro del negoziato climatico: inesorabilmente, si sciolgono. L’una prende il posto dell’altra, in una stratificazione di incontri che non fa recedere di un epsilon la tendenza inesorabile delle emissioni.
Occorre risparmiare il 15% del consumo di gas naturale nei 6 mesi da agosto 2022 a marzo 2023. È un atto di buon senso e ce lo chiede l’Unione Europea. Di qui il piano del Ministero della Transizione Ecologica che delinea una serie di azioni tese a risparmiare 8,2 miliardi di metri cubi (mld mc) di gas.
Un primo modo attraverso il quale leggere il piano del governo è attraverso la distinzione tra interventi sul lato dell’offerta e della domanda.