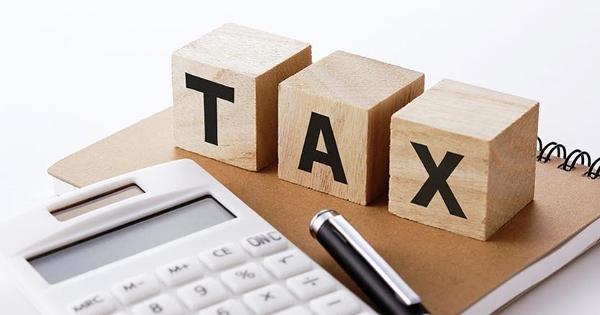ACQUA & AMBIENTE | 29 ARTICOLI
La risorsa idrica rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo dell’economia italiana, un driver di competitività che va tutelato in maniera sostenibile. Una delle maggiori sfide nell’ambito della gestione dell’acqua è rappresentata dalla continua modifica della disponibilità della risorsa, per quantità e qualità, accentuata dai cambiamenti climatici, con effetti che vanno dalle importanti variazioni dei regimi pluviometrici all’intensificazione dei fenomeni meteo estremi, oltre che dalla normativa sempre più stringente a tutela dai microinquinanti di nuova generazione.
L’emergenza idrica è tra i rischi a maggior impatto per il pianeta. La domanda mondiale di acqua è, infatti, prevista in aumento del 30% nei prossimi 30 anni, in considerazione della rapida crescita demografica ed economica, con un incremento repentino nei prossimi due decenni. Emerge dunque la necessità di elaborare politiche per una gestione sostenibile delle risorse idriche.
Pochi se ne sono accorti, ma quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della “legge Galli” (l.36/1994), la legge che trasformò radicalmente il sistema di gestione dei servizi idrici in Italia. Il compleanno ci dà l’occasione per un bilancio di quella riforma, e insieme per riflettere sull’adeguatezza di quel modello a fronte delle sfide che il settore ha di fronte, in primis quelle derivanti dal cambiamento climatico.
L’acqua è un elemento vitale e da sempre regola la vita sulla Terra, disciplinandone gli equilibri. Negli ultimi decenni i mutamenti nel clima globale hanno avuto conseguenze significative sul ciclo dell’acqua e sulle risorse idriche del pianeta. Eventi meteorologici estremi, come inondazioni e siccità, sono sempre più frequenti e intensi, comportando impatti negativi in tutto il mondo.
Con un deficit di precipitazione registrato su scala nazionale pari a circa il -24% rispetto alla media 1951-2020, il 2022 è stato uno degli anni più avari di precipitazioni negli ultimi anni. Le fasi siccitose, ormai sempre più frequenti, sono il sintomo di un mutamento nelle dinamiche climatiche, con ripercussioni evidenti anche sul ciclo idrologico.
In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, l’Istat ha pubblicato online un focus tematico che presenta una lettura integrata delle statistiche sulle acque condotte dall’Istituto, con particolare riferimento al triennio 2019-2021. L'acqua e l’insieme dei servizi a essa correlati sono elementi imprescindibili per la sostenibilità ambientale, il benessere dei cittadini e la crescita economica.
Il focus abbraccia diversi aspetti legati alla risorsa idrica, fornendo un approfondimento su: caratteristiche dei servizi idrici per uso civile; valutazione delle famiglie sul servizio idrico e sulle preoccupazioni ambientali; spese familiari sostenute per l’acqua; situazione degli apporti meteorici in Italia e nelle principali città; estrazione di acque minerali naturali a fini di produzione.
Alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Acqua, sono stati presentati i dati del Blue Book della Fondazione Utilitatis, realizzato in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e Istat e con il supporto di Utilitalia. Lo studio evidenzia come la gestione ottimale della risorsa idrica è un obiettivo imprescindibile per il diritto all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari ed ha impatti sociali, ambientali ed economici.
Meno entrate e più spese. Il processo di sostituzione a tappe forzate del parco veicolare da termico a elettrico avrà un impatto rilevante per la finanza pubblica. Proviamo a farne una stima di larga massima.
Circolano attualmente in Italia poco meno di 40 milioni di autovetture; quelle elettriche sono intorno a 200.000, numero raddoppiato rispetto al 2020. Lo scorso anno le immatricolazioni complessive sono state 1,5 milioni.
La quarta edizione del Catalogo sui sussidi ambientalmente dannosi (sad) e favorevoli (saf) stima in circa 21,6 miliardi di euro l’impatto degli uni e in circa 18,9 miliardi gli altri. A questi si aggiungono 13,6 miliardi di misure il cui impatto sull’ambiente è giudicato incerto. Il peso dei sad è in calo rispetto agli anni precedenti: l’aggiornamento delle stime relative al triennio trascorso fissa l’asticella a 22,3 miliardi nel 2017, 23,0 miliardi nel 2018 e 24,5 miliardi nel 2019. Per trovare un valore inferiore a quello del 2020, che ovviamente ha risentito del rallentamento dell’attività economica causato dal Covid-19 e dai lockdown, bisogna tornare al 2016 (20,3 miliardi).
L’allarme siccità nelle campagne italiane, dove si tenta di salvare le colture con le irrigazioni di soccorso, è la dimostrazione dell’importanza dell’acqua come vera e propria risorsa strategica nazionale. Infatti, la prolungata mancanza di precipitazioni insieme al caldo torrido stanno seccando la terra, svuotando le spighe, scottando la frutta e la verdura nei campi e provocando stress negli animali nelle stalle con il crollo della produzione di latte. In sofferenza ci sono dagli ortaggi alla frutta, dal mais alla soia, dal pomodoro ai cereali.