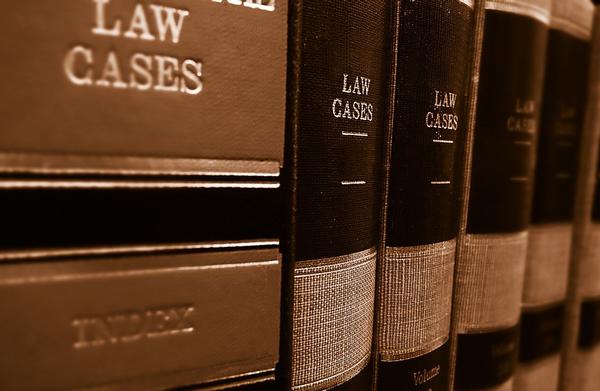Il settore dei rifiuti sta attraversando una fase di profonda trasformazione e di evoluzione strategica a livello europeo e nazionale. In poco più di 20 anni siamo passati dalla gestione dei rifiuti come scarti da cui liberarsi al nuovo paradigma economico dell’economia circolare dove i rifiuti diventano beni da riutilizzare o riciclare come materia prima seconda nei cicli produttivi in un’ottica di simbiosi industriale.
Tuttavia, il settore in Italia attraversa una profonda crisi che ha le sue radici nella poca lungimiranza degli enti competenti nel pianificare un’adeguata rete di impianti sul territorio nazionale.
Con l’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, l’art. 117 della Costituzione viene modificato in modo che contenga due elenchi con riferimento alla competenza legislativa dello Stato e delle Regioni. Uno per le materie di competenza esclusiva dello Stato. Uno per quelle di competenza concorrente Stato-Regioni.
L’evidente sovrapposizione (tra le altre) della materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” riservata allo Stato e quelle del “governo del territorio” e della “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” attribuite alla competenza concorrente Stato-Regioni, ha reso conflittuale il rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale in materia ambientale.
Lo scorso 4 giugno, il Gruppo Hera ha organizzato a Bologna presso la propria sede un evento dal titolo “L'ecosistema e la sua unitarietà: una sfida per il futuro sostenibile”. Di quale ecosistema parliamo nel caso della multiutility Hera?
Il nostro ecosistema è rappresentato dal territorio in cui ci muoviamo, operiamo, interagiamo. Un rapporto, basato su valori chiave, che dev’essere collaborativo e di vicendevole beneficio, per favorire crescita, sviluppo e sempre nuove opportunità per i portatori di interesse coinvolti.
La transizione energetica verso fonti rinnovabili, già percepita nel settore elettrico grazie allo sviluppo del fotovoltaico e dell’eolico, si sta progressivamente estendendo ad altre fonti dal potenziale “bio” ancora inespresso, che tanto possono dare in ottica di decarbonizzazione e di raggiungimento degli obiettivi sovranazionali. Tra queste vi è il biometano che, a seguito degli ultimi sviluppi sia della normativa primaria - con l’uscita del nuovo decreto 2 marzo 2018 per la promozione dell’utilizzo del biometano nei trasporti - sia della normativa tecnica di settore - con le norme CEN che hanno concluso il mandato M/475 sulla qualità - risulta finalmente pronto a dare il proprio contributo green nel processo di sostituzione dei carburanti tradizionali.
Secondo l’Osservatorio Media Permanente Nimby Forum, nel 2017 in Italia sono 359 gli impianti e le infrastrutture oggetto di contestazioni, il 5% in più rispetto all’anno precedente. Segno che ancora qualcosa non va nella comunicazione tra cittadini e industria. Di chi è colpa, dei primi o dei secondi? E che ruolo gioca la politica?
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 della Legge di Bilancio 2018, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e assimilati, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) è diventata ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La legge ha infatti assegnato all'Autorità la regolazione anche del settore rifiuti, con specifici compiti da esercitare con gli stessi poteri e nel quadro dei principi finora applicati negli altri settori già di competenza dell'Autorità (elettricità, gas, sistema idrico integrato e, in parte, teleriscaldamento), come fissati dalla propria legge istitutiva.
Nel ciclo di incontri con la politica la federazione ribadisce la necessità di investimenti e regolazione.
I prossimi appuntamenti il 26 febbraio con il Partito Democratico e il 1 marzo con Forza Italia
L'economia circolare, la sostenibilità, una regolazione che offra un quadro stabile entro cui muoversi con maggiore sicurezza per gli investimenti e che al tempo stesso garantisca sia i cittadini che le aziende, infine l'innovazione e l'attenzione particolare verso le città.
Tomaso Tommasi di Vignano (Presidente Esecutivo Gruppo Hera)
La strada che conduce al 2021 per il Gruppo Hera passa attraverso cinque parole chiave – crescita, efficienza, eccellenza, innovazione e agilità – sulle quali si fondano le strategie di sviluppo della multiutility bolognese. Un cammino che la società, da 4,4 miliardi di fatturato e 4,4 milioni di cittadini serviti (tra Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana e Veneto), ha tracciato nel nuovo Piano industriale presentato ai primi di gennaio, con una previsione di investimento di circa 2,9 miliardi di euro ripartiti in tutti i settori di riferimento.
Il contributo di Forza Italia è firmato dal suo capogruppo alla camera Renato Brunetta. Volto noto del partito con il quale è entrato nel 1999 a far parte del Parlamento Europeo. Dal 2008 al 2011 è stato Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Il contributo della Lega Nord è firmato da Matteo Salvini. Già consigliere comunale di Milano e deputato del parlamento Europeo, il 7 dicembre 2013 diventa segretario federale del partito, vincendo le primarie contro Umberto Bossi.