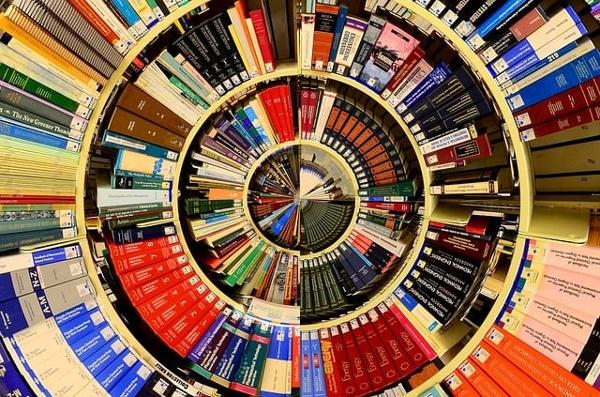Si riparla di nucleare, in Italia come in Europa. Diversi paesi hanno programmato o stanno pensando di pianificare nuove realizzazioni di impianti nucleari: la Francia si appresta a costruire almeno 6 grandi reattori EPR2, la Repubblica Ceca ha appena concluso una gara per 2 impianti di grande taglia, vinta dai coreani (i quali hanno battuto sia i francesi sia gli statunitensi), poi Polonia, Svezia, Romania, Finlandia, Slovacchia, Belgio, Olanda ed altri ancora, una dozzina in totale. Alcuni sono interessati solo ai reattori di grande taglia, altri principalmente agli Small Modular Reactors, altri a entrambi. Chi predilige acquistarli in Oriente, chi in Occidente oltreoceano o oltremanica, chi li svilupperà in casa.
Scelte e strategie differenti, ma tutte accomunate da un unico, grande problema: le risorse umane.
Si stima, infatti, che la sola Francia per i propri EPR2 avrà necessità di assumere 100.000 nuovi addetti nel settore nucleare, da qui al 2033. Dimensione di fabbisogno che si presume possa essere di circa 500.000 persone per l’intera Europa, mentre 4 milioni di nuovi professionisti sono stati stimati necessari di recente dalla IAEA per il comparto nucleare mondiale, entro il 2050.
Numeri che nei decenni passati non si sono mai visti.
La sfida appare subito impegnativa. Per vincerla occorre agire su più fronti: è necessario prima attrarre le giovani generazioni, poi formarle a più livelli (dai tecnici specializzati ai dottori di ricerca), ma si dovrà attirare anche tecnici e professionisti provenienti da altri settori industriali (automotive e Oil&Gas, ad esempio) e ri-addestrarli al nucleare.
Uno sforzo notevole, che potrà essere affrontato più efficacemente se si realizzerà una strategia collaborativa a livello europeo.
Ma rimaniamo in Italia. Il governo e i settori industriali nazionali, soprattutto quelli più energivori, sembrano decisamente interessati e disponibili a riaprire una stagione nucleare. Siamo ai primi “vagiti”: un disegno di legge-delega che deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri, poi discusso e approvato dal Parlamento, e una newco (ENEL, Ansaldo Nucleare e Leonardo) che deve fare da apripista sulle tecnologie, i modelli di realizzazione e di business, la costruzione di una filiera italiana, il coinvolgimento degli utenti industriali finali.
E quali e quante risorse umane dedicate serviranno? Certamente dipenderà dal numero e dal tipo di reattori che l’Italia sceglierà di realizzare. Una prima stima è stata redatta da Edison, in collaborazione con Ansaldo Nucleare, nello studio presentato al forum Ambrosetti a Cernobbio il settembre scorso: si parla di 117.000 occupati diretti, indiretti e indotti dal 2030/35 al 2050, per circa una ventina di reattori, SMR (small modular) e AMR (advanced).
Dai saldatori ai tecnici di laboratorio, dagli amministrativi agli ingegneri nucleari: una piramide di competenze alla cui base, in percentuale maggioritaria, stanno operai qualificati e tecnici specializzati, e in cima alla quale siedono proprio gli esperti nelle tecnologie nucleari, frutto dei percorsi di alta formazione. Proprio quest’ultima parte, minore in percentuale ma sempre grande nel numero e altamente specializzata nelle conoscenze e competenze, appare la più critica per il paese, che ha chiuso con i piani nucleari industriali ormai da oltre trent’anni.
È quindi una missione impossibile, che mina alla radice ogni velleità di ripresa di questa energia nel nostro paese? Sorprendentemente, pare proprio di no.
Infatti, sono sette le università italiane coinvolte sia nella ricerca che nella formazione sull'ingegneria nucleare, ancora impegnate a mantenere e sviluppare competenze sulle tecnologie nucleari in tutti i campi di applicazione: energetico, medico, ambientale. Molte di queste operano in questo settore fin dagli anni '50 (il primo corso di laurea in ingegneria nucleare fu lanciato a Milano nel 1954). Dal 1994, poi, si sono raggruppate nel CIRTEN, il consorzio interuniversitario per la ricerca tecnologica nucleare che riunisce i Politecnici di Milano e di Torino e le Università di Padova, Bologna, Pisa, Roma “La Sapienza” e Palermo.
Queste oggi continuano a offrire programmi di laurea magistrale in ingegneria nucleare, o in percorsi nucleari nell’ingegneria energetica, pressoché interamente impartiti in inglese, a circa 300 nuovi studenti che si iscrivono ogni anno: un numero da tre anni in crescita, spinto dal genuino ed entusiastico interesse delle giovani generazioni verso le applicazioni nucleari. Alle lauree si aggiungono i percorsi di dottorato di ricerca, con diverse decine di studenti coinvolti.
Il numero di nuovi iscritti è sorprendente, se si considerano le condizioni storiche nelle quali è maturato, soprattutto se si pensa che negli anni ’80, prima dell’incidente di Chernobyl, quando il paese aveva quattro centrali nucleari in funzione e una in costruzione, il numero massimo di laureati è stato di 280.
CIRTEN vanta anche una lunga tradizione di collaborazione didattica e scientifica con le aziende del settore nucleare, in Italia, in Europa e nel mondo. In passato, corsi per professionisti sono stati organizzati insieme alle industrie, mentre oggi sono in programma nuove iniziative, per istruire e formare esperti con background ingegneristici o scientifici non nucleari, in funzione delle esigenze industriali.
Fin dalla nascita CIRTEN ha posto come obiettivo chiave la partecipazione ai progetti Euratom di ricerca&sviluppo e di education&training. Il livello di successo nella partecipazione ai progetti Euratom è aumentato negli ultimi anni: ad ogni bando, almeno 4-5 progetti vedono la presenza delle sue Università. Purtroppo, questa performance in ambito europeo non può essere replicata a livello nazionale, perché dal 2018 sono state azzerate (dall’allora governo) le opportunità di finanziamento.
CIRTEN è anche membro fondatore della European Nuclear Education Network (ENEN), l’associazione che raggruppa tutte le università nucleari europee, oltre 60, nonché membro di FuseNet, che promuove e supporta a livello europeo il networking nell’ambito dell’educazione alla fusione nucleare, e della World Nuclear University, una iniziativa internazionale. Inoltre, diversi professori e ricercatori del CIRTEN collaborano con organizzazioni sovranazionali di riferimento, in particolare l’agenzia internazionale dell’energia atomica (IAEA) e l’agenzia dell’energia nucleare dell’OCSE (NEA).
Le competenze e le relative capacità di formazione spaziano dalla fisica dei reattori agli impianti nucleari (a fissione e a fusione), dalla sicurezza nucleare alla radiochimica, dalla radioprotezione all'affidabilità-disponibilità-manutenzione, alla misura e strumentazione delle radiazioni. Nei sette atenei sono disponibili laboratori sperimentali dedicati, incluso il reattore di ricerca AGN-201 presso l’ateneo di Palermo, potenzialmente utilizzabile dall’intera comunità accademica per il training di giovani studenti. Inoltre sono attive collaborazioni che consentono l’accesso a strutture esterne, ad esempio il TRIGA dell’Università di Pavia, unico reattore di ricerca oggi attivo nell’accademia italiana, ma anche i reattori TRIGA e TAPIRO presso il centro ENEA della Casaccia, i laboratori SIET di Piacenza, centro di livello internazionale per la sperimentazione termoidraulica di grandi componenti e sistemi nucleari, i laboratori di ENEA presso il Brasimone, per la sperimentazione di tecnologie per reattori a fissione di IV generazione, il centro di Frascati per la progettazione e la realizzazione della macchina a fusione DTT, i progetti sperimentali sempre per la fusione del Consorzio RFX di Padova, infine il centro di adroterapia CNAO di Pavia, per l’impiego di fasci di particelle per trattamenti radioterapici avanzati.
Le competenze di CIRTEN sono dedicate ad attività di ricerca&sviluppo su argomenti quali i reattori innovativi a fissione nucleare, gli SMR e i reattori di IV generazione, la termoidraulica dei reattori nucleari, i metodi di trasporto dei neutroni, la progettazione e la sicurezza dei reattori (compresi i sistemi di sicurezza passivi), l’impatto e la protezione dell’ambientale, gli aspetti economici, lo smantellamento delle centrali e la gestione dei rifiuti, la fisica e l’ingegneria dei reattori a fusione (dalla superconduttività alla criogenia, dalla termofluidodinamica alla termomeccanica, dalla neutronica alla sicurezza), il combustibile nucleare e il ciclo del combustibile, nonché le applicazioni industriali e quelle medicali delle radiazioni (dalle schermature alla nuova strumentazione per la misura e la caratterizzazione dei campi di radiazione).
L'approccio multidisciplinare e la formazione sperimentale nel percorso formativo, insieme all'esperienza di ricerca durante il lavoro di tesi finale, solitamente svolta in collaborazione con organizzazioni nazionali e internazionali (università, centri di ricerca, aziende), sono i tratti distintivi dei percorsi di laurea magistrale e di dottorato italiani.
Proprio la collaborazione su azioni di formazione e ricerca nelle tecnologie nucleari con entità italiane e straniere (dal Giappone agli Stati Uniti) è parte del “patrimonio genetico” del consorzio e può rivelarsi caratteristica preziosa per assolvere la missione (possibile) di formare nuove generazioni di esperti nucleari. Soprattutto per l’Italia, se deciderà di procedere sulla strada dell’atomo. Comunque, a favore delle aziende italiane (che pur rappresentano il secondo gruppo come dimensione nella supply chain nucleare europea) e di quelle straniere, che saranno certamente coinvolte nei progetti di rilancio e di sviluppo della fissione e della fusione in Europa.