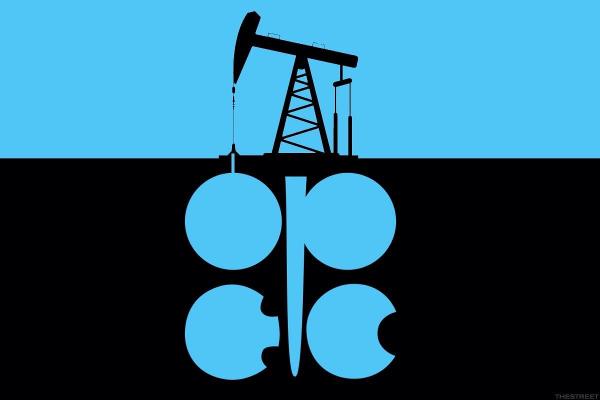Sebbene il realizzarsi della profezia del ministro saudita Sheikh Zaki Yamani sulla fine dell’era del petrolio sia ancora ben lontano, è innegabile che il settore petrolifero stia vivendo un processo di trasformazione epocale, nei confronti del quale i principali attori globali - OPEC in primis - sembrano dover ancora prendere le contromisure adeguate. Infatti, il periodo d’oro del greggio, culminato con il picco del prezzo del barile a $114 nel giugno del 2014, sembra storia ormai lontana. Nei mesi successivi il valore del petrolio è sceso rapidamente (minimo di 27 dollari al barile nel gennaio 2015), per poi lentamente stabilizzarsi - fino ai giorni nostri - in un intervallo tra i 50 e 70 dollari al barile. E nonostante continue turbolenze geopolitiche in alcuni paesi produttori chiave, primo fra tutti il Venezuela, l’oro nero non sembra proprio destinato a cambiare andamento.
Tutto nasce, evidentemente, negli Stati Uniti, attorno al 2007-2008. L’uso in combinato di tecniche di perforazione orizzontale e di fracking idraulico hanno infatti proiettato gli Stati Uniti attraverso un secondo boom petrolifero, ben più rapido e intenso di quello ventennale sperimentato tra gli anni ’40 e ’60 dello scorso secolo, motore chiave della supremazia globale a stelle e strisce. Una crescita, quella del ‘non-convenzionale’ che ha fatto schizzare la produzione americana - scesa attorno ai 5 milioni di barili giorno nella prima metà degli anni 2000 - oltre i 12 milioni registrati nel luglio di quest’anno.
Grazie a questa crescita esponenziale, gli Stati Uniti sono oggi il primo paese produttore di greggio al mondo, e tengono a distanza grandi player globali come Russia (produzione scesa sotto la soglia degli 11 milioni di barili/giorno, ai minimi dal 2016) e Arabia Saudita (già al di sotto dei 10 milioni di barili prima degli attacchi alle facilities di Abqaiq e Khurais dello scorso 14 settembre). A ciò si aggiunge il nuovo ruolo del greggio americano sui mercati globali, in seguito alla rimozione del bando alle esportazioni - adottato nel 1975 in seguito al primo shock petrolifero - da parte dell’Amministrazione Obama nel 2015. Nel luglio del 2019 l’export ha registrato il picco storico di 3.3 milioni di barili/giorno, che sommati alla commercializzazione di quasi 6 milioni di barili prodotti raffinati hanno portato Washington in cima alla classifica dei paesi esportatori.
In questo contesto evolutivo, sebbene l’idea di indipendenza energetica - spesso sventolata (a vanvera) nel dibatto interno americano - difficilmente potrà realizzarsi in modo concreto, appare evidente come la portata innovatrice dello shale statunitense sia in grado di modificare in modo irreversibile i fondamentali e condizionare il funzionamento dei mercati globali.
Questi numeri, seppur impressionanti, non bastano a fotografare la portata rivoluzionaria del “non-convenzionale” americano. Quello che le produzioni di Permian, Bakken e Eagle Ford e delle altre centinaia di siti sparsi per i 50 stati della federazione hanno introdotto nel mercato petrolifero rappresenta una sorta di rivoluzione copernicana per il settore. Lo shale ha, infatti, introdotto significativi livelli di flessibilità e liquidità sul lato dell’offerta ad un settore da sempre caratterizzato da una forte rigidità produttiva. La flessibilità e la maggiore elasticità delle nuove produzioni americane, fattori dettati dalle caratteristiche industriali intrinseche nel mercato shale, permettono ai produttori statunitensi di rispondere in modo più rapido ed efficace ai segnali di prezzo, contribuendo in questo modo a limitare le tendenze rialziste per il valore del barile (nonostante una situazione geopolitica incandescente, caratterizzata da tensioni in Venezuela, Libia, Nigeria e Iran, ai quali si aggiungono i recenti avvenimenti in Arabia Saudita).
A ciò si deve aggiungere una dimensione di lungo periodo, determinata dalla crescente consapevolezza dei rischi legati al cambiamento climatico. Con l’Accordo di Parigi infatti, tutti i grandi player globali si sono assunti la responsabilità internazionale di limitare il surriscaldamento del pianeta Terra identificando target e traiettorie (più o meno ambiziosi) di decarbonizzazione delle loro economie. Il tutto, con un ovvio impatto sui futuri consumi di combustibili fossili: carbone in primis, petrolio in seconda battuta, e infine gas naturale, il meno inquinante dei tre e considerato il ‘combustibile ponte’ della transizione energetica. Nonostante le principali e più autorevoli proiezioni escludano un crollo significativo dei consumi globali di greggio da qui ai prossimi decenni (secondo la IEA la domanda non raggiungerà il picco prima del 2040), la sfida della mobilità alternativa - incarnata dai veicoli elettrici ma anche da nuove soluzioni a gas sulle lunghe distanze e sui trasporti marittimi - rappresenta un grosso punto di domanda per il mercato petrolifero globale. In questo contesto, la scommessa cinese sulla mobilità sostenibile - incarnata dalla strategia “Made in China 2025” e confermata dal dominio di Pechino nei settori dell’auto elettrica e delle batterie - sembra confermare le criticità per il settore petrolifero.
I produttori tradizionali sembrano aver perso la bussola di fronte a queste sfide sistemiche. L’inazione dell’OPEC nel biennio 2014-2016, ma anche gli effetti parziali innescati dai tagli effettuati dal Cartello per scongiurare livelli troppo bassi dei prezzi del greggio, sono la cartina tornasole della confusione che regna tra i paesi produttori in questo nuovo contesto di mercato. L’irrilevanza rappresenta una minaccia seria per il gruppo dei paesi produttori, minacciati da prezzi bassi ed estremamente volatili e da tendenze di lungo periodo che spingono vero crescente sforzi di decarbonizzazione su scala globale.
Per far fronte a tali difficoltà, la risposta più ovvia e immaginabile è stato il tentativo di coinvolgere la Russia, e la dozzina di paesi non-OPEC che tendono ad allinearsi alle politiche petrolifere di Mosca, nelle dinamiche collaborative in seno al Cartello. Ma se l’idea di una R-OPEC in grado di rimpiazzare l’ormai desueto ruolo dell’Organizzazione di Vienna può sembrare suggestiva e vincente, è innegabile che la creazione di un gruppo di produttori così variegato ed eterogeneo in termini di risorse ed obiettivi strategici determina una crescente complessità e incertezza nella gestione congiunta dell’offerta globale di greggio. Un circolo vizioso, dal quale Riad e Mosca, e a seguire tutti i paesi alleati, non hanno ancora trovato il modo di uscire indenni.