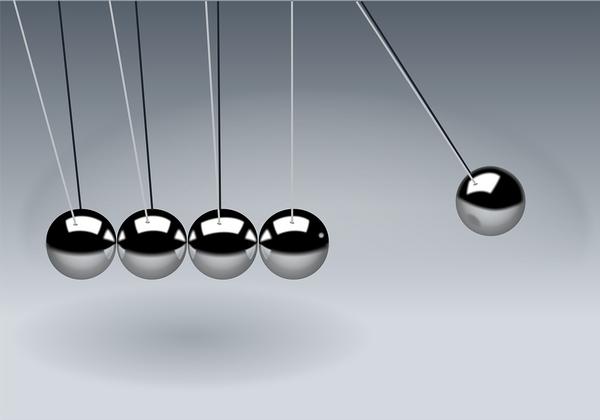L’avvento della cosiddetta shale revolution nel 2010, la rivoluzione del petrolio e gas di scisto targata USA, ha determinato una serie di ripercussioni sul mercato Oil&Gas. In particolare, la produzione americana di shale oil ha impattato in maniera significativa sui prezzi del greggio, sulla geopolitica globale, sul futuro delle forniture petrolifere, sulle variabili macroeconomiche e, non da ultimo, sullo sviluppo delle fonti rinnovabili. Una rivoluzione che sta cambiando il panorama dell’industria del petrolio e del gas su scala mondiale. Basti pensare che gli Stati Uniti sono tornati ad essere esportatori di greggio, prodotti raffinati e gas naturale: le importazioni di greggio si sono ridotte del 25%, dai 9,86 milioni di barili al giorno (mil. bbl/g) del 2010 ai 7,39 mil. bbl/g del 2016; in termini di prodotti raffinati, si è passati da 2 mil. bbl/g di importazioni nette nel 2007 a 2,5 mil. bbl/g di esportazioni nette nel 2016, esportazioni che tra l’altro sembrano sulla buona strada per raggiungere un nuovo record di crescita nel 2017.
Impatti sui prezzi del petrolio.
Non vi è dubbio che la produzione statunitense di olio di scisto sia stata tra i principali fattori che hanno portato ad un dimezzamento dei prezzi del petrolio a partire da luglio 2014. Prezzi che sono riusciti a risalire sopra la soglia dei 60 dollari al barile solo in seguito all’implementazione di un taglio cumulato della produzione di 1,8 mil. bbl/g avviato nel gennaio 2017 dall’Opec guidata dall’Arabia Saudita e da alcuni paesi non-OPEC capeggiati dalla Russia. Un taglio che proprio lo scorso 30 novembre è stato prolungato per tutto il 2018.
Un incarico non facile quello assunto dall’OPEC, soprattutto in termini di coesione. L’Arabia Saudita si trova di fronte ad un dilemma: da un lato, non può tornare alla vecchia strategia di inondare i mercati con il suo greggio; dall’altro, non vuole trovarsi a sostenere da sola il peso di nuove riduzioni perché si tradurrebbero in una perdita sia economica che strategica, erodendo la sua quota di mercato. La Russia poi ha dichiarato che la propria economia potrebbe sopravvivere senza problemi con un prezzo del petrolio stabile sui 40 dollari al barile o meno. Viene quindi da chiedersi quanto a lungo il paese di Putin continuerà a rispettare la strategia sottoscritta con l’OPEC. In mancanza di quotazioni più elevate del greggio, il Regno saudita si troverà ad affrontare una crisi finanziaria imminente: le riserve di valuta straniera sono calate da una stima di 744 miliardi di dollari nel luglio 2014 a circa 494 miliardi nel giugno 2017. Per sua fortuna, gli analisti prevedono il verificarsi di una condizione di ammanco di offerta entro il 2020, specie in ragione del calo degli investimenti correlato ai bassi prezzi degli ultimi tre anni. Le attese sono quindi di un aumento dei prezzi nel medio termine.
Implicazioni geopolitiche
Sul fronte geopolitico, lo shale oil americano ha stravolto gli equilibri in essere tra le principali aree di produzione e quelle di consumo. L’evidenza più grande di questo sconvolgimento è il Medio Oriente. Le relazioni tra questa regione, la più importante in termini di produzione petrolifera, gli USA e i paesi OCSE, ossia i principali consumatori su scala globale, potrebbero presto cambiare e in maniera del tutto imprevedibile.
Prima del 1993, la Cina si classificava tra gli esportatori netti di petrolio e, più in generale, di energia. Vent’anni più tardi, nel 2013, prendendo il posto degli Stati Uniti, è diventata il più grande importatore di petrolio, ruolo che entro il 2030 si estenderà con grosse probabilità anche a gas naturale e carbone. A quel punto, l’80% del consumo cinese di petrolio e il 40% di quello di gas dipenderanno dalle importazioni. L’Europa, dal canto suo, rimarrà probabilmente un’area di importazione significativa di fonti fossili. Sul fronte opposto, gli Stati Uniti saranno autosufficienti in termini energetici, o meglio, quasi autosufficienti. Sono già diventati esportatori netti di carbone e GNL e le importazioni petrolifere sono in continuo calo, anche se per questa fonte rimarranno importatori netti ben oltre il 2030. Sempre in ambito oil, minori importazioni si combinano con una loro crescente diversificazione geografica (Nigeria, Canada, Messico e Angola). In questa cornice, il ruolo del Medio Oriente come importante fornitore petrolifero mondiale potrebbe ridursi.
Implicazioni macroeconomiche
Mentre prezzi del petrolio più bassi potrebbero sostenere una crescita generalizzata del PIL a stelle e strisce in un range che oscilla tra lo 0,75% e l’1,5%, il colpo più grosso lo inferirebbero alla sempre più importante industria petrolifera USA. Gli svantaggi per l’economia statunitense possono essere di due tipi. Il primo riguarda il ruolo che il settore petrolifero sta rivestendo nel sistema economico. Negli ultimi otto anni, anche in virtù della shale revolution, la produzione americana è aumentata del 50% da circa 6 mil. bbl/g nel 2008 a 9 mil. bbl/g nel 2016. Tuttavia, ad un prezzo del barile inferiore ai 60 dollari, gran parte dell’industria shale non è più redditizia. Questo sta già causando una serie di importanti tagli sia negli investimenti che nel personale, in un settore che, è bene ricordarlo, è fonte di reddito e lavoro per circa il 2% della popolazione USA. Sta inoltre crescendo il rischio di insolvenza per quanto riguarda gli oltre 200 miliardi di dollari di finanziamenti concessi ai produttori shale. Il secondo svantaggio connesso al declino dei prezzi delle commodities internazionali è la spinta verso la recessione che ne può derivare per le principali economie emergenti come Brasile, Russia e Sudafrica, con un impatto negativo sulla ripresa dell’economia statunitense e quindi mondiale.
Implicazioni ambientali
Nel 2015 gli Stati Uniti hanno registrato il maggior declino su scala mondiale delle emissioni di CO2 prodotte, grazie alla sostituzione del carbone nella generazione elettrica con il più economico shale gas. Nell’Unione Europa, al contrario, le emissioni di anidride carbonica sono diminuite solo marginalmente, sostanzialmente come effetto collaterale della recessione economica. L’intensità carbonica europea è invece cresciuta, dal momento che le importazioni di Gas Naturale Liquefatto (GNL) destinate alla generazione elettrica sono state sostituite dal carbone di provenienza americana, divenuto nel frattempo più economico.
Com’era prevedibile, le quantità di gas americano non sfruttate dall’Europa si sono dirette verso l’Asia, dove vi è un mercato disposto a pagare bene e dove hanno consentito al Giappone di ovviare all’ammanco di energia nucleare. In Europa, la quota di carbone aumenta a dispetto di quella del gas naturale; negli Stati Uniti avviene il contrario. Le conseguenze in termini di emissioni di carbonio sono ovvie.
La domanda sorge quindi spontanea. Cosa accadrà nel breve termine? Vinceranno le preoccupazioni ambientali che circondano l’uso del fracking o la convinzione che consumare più gas, compreso quello di scisto, significa bruciare meno carbone? Il fracking è un problema locale, le emissioni sono una questione globale. Purtroppo sappiamo come queste storie vanno a finire.