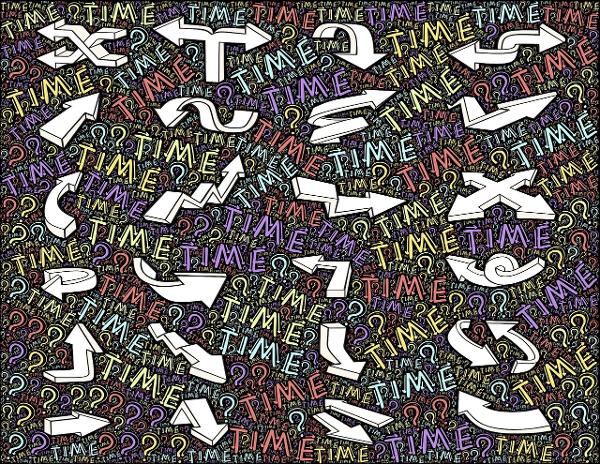Negli ultimi anni il lessico della gestione dell’incertezza si è arricchito di una parola entrata stabilmente nel linguaggio pubblico: permacrisis, eletta parola dell’anno dal Collins Dictionary nel 2022. Non indica una crisi particolarmente lunga, ma una condizione in cui le discontinuità non rappresentano più eccezioni temporanee: sono diventate una caratteristica permanente del contesto. Nel settore energetico, da sempre collocato all’intersezione tra geopolitica, tecnologia, finanza e clima, questa trasformazione è particolarmente evidente.
La sequenza che va dalla pandemia alla guerra in Ucraina, dall’inflazione alla crisi dei semiconduttori, dallo shock energetico europeo alla volatilità dei mercati delle materie prime, ha mostrato quanto sia difficile ricondurre gli eventi a schemi previsionali consolidati. Non è solo una questione di “più incertezza”. La relazione tra cause ed effetti è sempre più opaca; gli shock locali si propagano lungo catene del valore globali e generano effetti di secondo e terzo ordine difficili da anticipare. Oscillazioni improvvise dei prezzi, riconfigurazioni della domanda e tensioni normative e geopolitiche sono solo alcuni dei segnali che rendono il sistema energetico-ambientale sempre più complesso.
In questo scenario emerge un punto centrale: non basta prevedere di più e nemmeno prevedere meglio. Le aziende producono oggi la mappa dei rischi derivante dal processo di risk assessment, che contiene centinaia di rischi classificati, valutati e sottoposti a sensitività numeriche sempre più raffinate. Ma questo serve per il prevedibile. Al più può essere utile se stimola un pensiero esplorativo, mantiene aperta la mente e rafforza risorse e competenze su cui fare leva ex ante. Diventa però dannoso quando produce un effetto di rassicurazione: l’idea, implicita e diffusa, che tutto ciò che conta sia stato mappato. Nell’imprevedibile, infatti, è proprio il rischio residuo, ciò che non rientra nelle categorie note, a diventare rilevante e prorompente. Se l’imprevedibile non può essere tradotto in categorie di rischio, come possiamo allora approcciarlo? La risposta passa dal ripensare le categorie con cui interpretiamo la realtà e dal chiarire cosa intendiamo davvero per imprevedibile.
La letteratura organizzativa mostra che sotto questa etichetta convivono fenomeni molto diversi. I rare events (Vaughan, 1990) sono eventi a bassissima frequenza, che sfuggono alle logiche statistiche standard. Gli extreme events (Perrow, 1984) sono definiti dall’intensità dell’impatto più che dalla probabilità. Gli unexpected (Weick & Sutcliffe, 2001) hanno una natura cognitiva: sorprendono perché non rientrano nei modelli mentali delle organizzazioni. I black swans (Taleb, 2007) introducono un livello ulteriore: non solo non anticipabili, ma non derivabili dal passato. Gli unthinkable (Weick, 1998) sfuggono persino all’immaginazione; gli unexampled (Westrum, 2006) non hanno precedenti comparabili; e le new emergencies (Frigotto, 2020; 2022) emergono dall’intreccio fra domini un tempo separati, tecnologici, fisici, finanziari, generando forme ibride non ancora classificate e che richiedono la produzione di nuova conoscenza per essere comprese.
Questa tassonomia non è un esercizio teorico: mostra che l’imprevedibilità non è un’“incertezza più difficile”, ma un salto di qualità che tocca direttamente la nostra capacità di immaginare. Frank Knight, già nel 1921, distingue tra rischio (dove le alternative sono associate a probabilità note), incertezza calcolabile (dove scenari e alternative sono difficilmente stimabili) e incertezza radicale, o ignoranza (dove gli stati del mondo non sono nemmeno formulabili). L’imprevedibile contemporaneo oscilla tra queste dimensioni, ma nella sua forma più dirompente, e negli ultimi anni ne abbiamo viste molte manifestazioni, appartiene al terzo tipo: non manca solo il dato, manca la categoria con cui immaginare lo scenario, e quindi la capacità di percepirlo e descriverlo tempestivamente.
Il settore energetico è oggi uno dei contesti in cui questo si manifesta con maggiore chiarezza. L’interdipendenza crescente tra infrastrutture fisiche e sistemi digitali, la differenza di scala tra i tempi decisionali umani e quelli delle macchine e l’ibridazione tra energia, clima, geopolitica e finanza hanno prodotto un sistema ad accoppiamento forte (tightly-coupled). In un contesto di questo tipo, piccoli shock possono propagarsi con velocità e intensità che sfuggono alla previsione lineare, la stessa su cui per decenni si è fondata la pianificazione strategica.
In questo quadro, la resilienza diventa una lente più adatta del tradizionale risk management. Non perché la previsione non sia più utile, ma perché non può essere l’unico strumento in un mondo dove gli stati futuri non sono dati, ma emergono mentre gli attori interagiscono. La resilienza consente di distinguere tre modalità di risposta: l’assorbimento, l’adattamento e la trasformazione. L’assorbimento è tipico delle infrastrutture critiche che devono ripristinare rapidamente la funzionalità, come accade nei blackout elettrici dovuti a eventi climatici estremi. L’adattamento emerge quando lo shock modifica durevolmente procedure e modelli operativi, come è accaduto con la digitalizzazione accelerata imposta dalla pandemia. La trasformazione si manifesta invece quando la perturbazione apre la strada a un ripensamento radicale. Nel mondo dell’energia, un esempio chiaro è il modo in cui lo shock dei prezzi del gas del 2021–2022 ha accelerato, in molti Paesi europei, non solo investimenti nelle rinnovabili, ma un ridisegno complessivo dei modelli di approvvigionamento, della governance del sistema elettrico e della struttura dei mercati: lo shock non ha solo modificato pratiche operative, ha avviato una vera riconfigurazione strategica.
Per imprese, istituzioni e gestori di infrastrutture energetiche, la domanda cruciale diventa allora quale combinazione di stabilità e cambiamento permetta di operare in una condizione di permacrisi. Una possibile risposta passa attraverso la comprensione delle interdipendenze più che dei singoli rischi, l’apertura cognitiva necessaria per riconoscere la novità e la capacità di distinguere ciò che è davvero rilevante per la continuità della propria value proposition da ciò che è semplicemente inatteso ma marginale.
In un’epoca in cui gli shock si sovrappongono, la vera capacità competitiva non risiede nel prevedere l’imprevedibile, ma nel costruire organizzazioni capaci di evolvere mentre il contesto si trasforma. A ciò servono apertura cognitiva, una cultura non del controllo ma della co-evoluzione, e tempi e spazi dedicati all’esplorazione di mondi possibili che la sola focalizzazione sull’efficienza non consentirebbe di vedere. In fondo, riconoscere che l’imprevedibile è portatore di novità, e non solo di minacce, è il primo passo per sviluppare quella resilienza adattiva e trasformativa che permette non solo di resistere agli shock, ma di usarli come leva per immaginare e costruire futuri diversi.