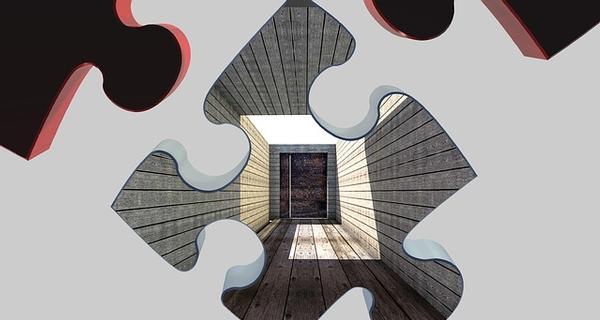Le immagini di guerriglia “campestre” che ci sono arrivate in questi giorni dal Salento con la polizia in assetto da guerra tra gli ulivi, ci ricordano ancora una volta l’urgenza di affrontare con altri mezzi le contestazioni contro le grandi opere. I cittadini che protestano contro un gasdotto, in questo caso, o contro un elettrodotto, un inceneritore, un rigassificatore, una linea ad alta velocità e contro molte altre cose ancora, respingono con sdegno l’etichetta NIMBY (Not In My Back Yard) che viene loro regolarmente affibbiata. E non hanno tutti i torti, perché si tratta di un epiteto malevolo che è stato inventato per colpevolizzarli. Per fortuna abbiamo anche a disposizione l’acronimo più neutrale, LULU (Locally Unwanted Land Use), che descrive perfettamente il fenomeno. Qui abbiamo infatti costantemente a che fare con “usi del territorio localmente indesiderati”.
Questo fenomeno non è nato in Italia (come gli acronimi inglesi rivelano). Ma poi, una volta comparso sulla nostra scena, è riuscito ad attecchire in modo floridissimo, fino a diventare onnipresente da un capo all’altro della penisola. Perché? La diffusione della sindrome Nimby o Lulu, che dir si voglia, è il frutto della congiunzione di due fattori che sono particolarmente sviluppati in Italia: l’arroganza e la chiusura. L’arroganza aggressiva del potere. E la chiusura difensiva delle comunità locali.
L’arroganza aggressiva
Abbiamo importato l’espressione Nimby allo scopo di irridere le proteste locali, ma non siamo stati finora capaci di osservare quello che gli altri paesi hanno appreso a furia di sbattere il muso contro le reazioni delle comunità locali. Nei paesi del Nord Europa, in Francia, nel Nord America e anche in Giappone, chi progetta opere invasive sa che deve, prima ancora di cominciare, porsi in posizione di ascolto, discutere e negoziare con le comunità locali. Sono stati elaborati approcci specifici che assumono svariate denominazioni come Alternative Dispute Resolution, Débat Public, Environmental Mediation, Consensus Building, Multistakeholder Environmental Partnerships ecc. In Italia invece si continuano a progettare gli interventi come se le comunità locali non esistessero.
Si tracciano segni sulla carta, ci si conforma ai dettami di una tecnologia iper-modernizzante (e culturalmente obsoleta), ci si fa scudo di un “interesse generale” che parrebbe autorizzare ogni sorta di deformazione del territorio. I politici si trincerano dietro i miti del progresso, della velocità, della modernità e poi delegano l’esecuzione ai tecnici. I tecnici, a loro volta, applicano ciecamente le loro routines, ricavate da manuali ormai superati. I formidabili interessi che stanno alle spalle di questi interventi premono senza sosta perché si realizzi tutto quanto e presto, senza cambiare una virgola. Quello che, al massimo, riescono a inventarsi quando scoppiano le proteste è il ricorso a una parola magica: comunicazione. Ecco allora spuntare dépliant patinati, punti informativi in cui graziose hostess distribuiscono sorrisi e mostrano attraenti video, siti web – rigorosamente non interattivi – che non contengono nessun documento e nessuna vera informazione.
La chiusura difensiva
Dall’altra parte si manifesta la crescente reattività delle comunità locali. Esse ormai tendono a chiudersi a riccio di fronte a qualsiasi cambiamento imposto dall’esterno. Spesso i conflitti di questo tipo vengono designati come “conflitti ambientali”. Ma la difesa dell’ambiente è solo un aspetto (spesso secondario) o addirittura un pretesto per dare una qualche dignità alla protesta. I conflitti Nimby nascono come una difesa del proprio territorio contro un’invasione percepita come minacciosa. Quello che i cittadini temono è che l’opera progettata sconvolga i loro ritmi di vita, degradi la loro comunità o faccia diminuire il valore delle loro proprietà immobiliari. Reagiscono contro un possibile declassamento. La difesa oltranzista del territorio ha indubbiamente un aspetto nobile: è una reazione di riscatto dopo tanti oltraggi subiti nel passato. Ma ha anche aspetti inquietanti. L’iper-sensibilità per la conservazione dello status quo, è anche il frutto di un ripiegamento e di una chiusura verso il mondo globalizzato e contro i flussi che lo attraversano. Queste paure vengono spesso declinate in termini di difesa dell’ambiente e della salute (la diossina, l’amianto, le radiazioni nucleari ecc.), ma la loro origine è un’altra. Gli ambientalisti sono portati a sostenere a spada tratta queste proteste. Ma forse potrebbero essere più cauti. Le reazioni locali si rivolgono indistintamente contro opere ambientalmente discutibili (depositi di scorie nucleari, inceneritori, centrali elettriche), ma anche contro insediamenti ambientalmente virtuosi (impianti eolici) o, addirittura, contro insediamenti umani sgraditi (come i campi nomadi, i centri di ricupero per tossicodipendenti, i centri di cura per malati mentali). Le motivazioni sono sempre le medesime e anche la dinamica della protesta.
Cambiare rotta: il dibattito pubblico
Siamo così arrivati a un circolo vizioso. L’arroganza alimenta la chiusura. La chiusura spinge i promotori verso un surplus di arroganza allo scopo di sbaragliare le resistenze locali. Il risultato è un muro contro muro, circondato da diffidenze, sospetti, disprezzo reciproco e, possiamo dire, un progressivo degrado della vita civile. Se ne può uscire? Negli ultimi anni abbiamo cominciato a guardare quello che si sta facendo altrove. L’anno scorso l’art. 22 del codice degli appalti ha previsto di rendere obbligatorio il dibattito pubblico sulle grandi opere, secondo il modello francese. Anche da noi, prima dell’approvazione del progetto preliminare (oggi progetto di fattibilità) ci sarà un periodo di sospensione di alcuni mesi dedicato al coinvolgimento dei cittadini e delle loro associazioni nella discussione sul progetto, sulla sua opportunità e sulle sue caratteristiche. Ci saranno occasioni per individuare soluzioni alternative, per negoziare, per rivedere, anche radicalmente, il progetto. Un soggetto indipendente garantirà la corretta conduzione del processo. Questi dovrebbero essere i tratti fondamentali del dibattito pubblico, quale dovrebbe uscire dal regolamento attuativo che il governo è tenuto a presentare in Parlamento entro la fine di aprile del 2017. Non sarà facile contrastare l’arroganza dei proponenti e la chiusura difensiva delle comunità locali, ma uno strumento in questa direzione ormai dovrebbe esistere anche in Italia.